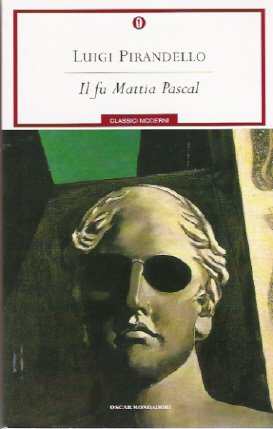I quaderni di Serafino Gubbio operatore
Luigi Pirandello: cenni biografici
Luigi Pirandello nasce ad Agrigento (l’antica colonia greca di Akragas che si chiamerà Girgenti fino al 1927) in una tenuta paterna detta “il Caos”, da Stefano Pirandello, garibaldino durante la spedizione dei Mille, e da Caterina Ricci-Gramitto, sposata nel 1863, sorella di un suo compagno d’armi, di famiglia tradizionalmente antiborbonica (questo dato autobiografico sarà importante durante la stesura del romanzo I vecchi e i giovani.
Frequentata la scuola nella città natale fino al secondo anno presso l’Istituto Tecnico, dal 1880 lo troviamo a Palermo dove frequenta gli studi liceali e dove la famiglia si era trasferita dopo un dissesto finanziario. Conseguita la licenza liceale si iscrive contemporaneamente sia alla Facoltà di Legge che a quella di Lettere dell’Università di Palermo e nel 1887 si trasferisce alla Facoltà di Lettere dell’Università di Roma, dalla quale è costretto, dopo un diverbio con il preside della Facoltà e docente di Latino Onorato Occioni, ad allontanarsi. Si iscrive, allora, all’Università di Bonn dove si reca con una lettera di presentazione del Professore di filologia romanza Ernesto Monaci.
A Bonn all’inizio del mese di gennaio 1890, conosce a una festa da ballo in maschera Jenny Schulz-Lander, alla quale dedica il suo secondo volume di poesie, dal titolo Pasqua di Gea, una ragazza (“una delle bellezze più luminose che io mi abbia mai visto”, scrive alla sorella Lina) di cui si innamora e che rivestirà una parte importante nella sua vita anche sul piano spirituale, in quanto gli rimarrà per sempre dentro l’amarezza di un amore non realizzato, l’unico vero della sua giovinezza. Si laurea nel 1891 con una tesi su Suoni e sviluppi di suono della parlata di Girgenti.
Nello stesso anno rientra in Italia e si stabilisce a Roma con un assegno mensile ottenuto dal padre. Nel 1894 sposa Maria Antonietta Portolano, figlia di un socio del padre, e l’anno seguente nasce il primo figlio, Stefano. Dopo le prime opere di poesia, scritte in Germania, a Roma comincia a collaborare a giornali e riviste con articoli e brevi studi critici e nel 1897 accetta l’insegnamento presso l’Istituto Superiore di Magistero femminile di Roma.
Nel 1897 e nel 1899 gli nascono i figli Rosalia (Lietta) e Fausto. Il 1893 è un anno particolarmente difficile, perché un allagamento nella miniera di zolfo del padre, nella quale aveva investito la dote patrimoniale della moglie, provoca il dissesto finanziario suo e del padre insieme ai primi segni della malattia mentale della moglie, che si aggraverà sempre di più fino ad essere ricoverata in ospedale. Nel 1901 pubblica il romanzo L’esclusa (scritto nel 1893) e nel 1902 Il turno; nel 1904 ottiene il primo vero successo con Il fu Mattia Pascal. Nel 1908 diventa ordinario dell’Istituto superiore di Magistero, risolvendo in parte i suoi problemi economici, e pubblica due importanti saggi:
L’umorismo e Arte e Scienza, che scateneranno un contrasto molto vivace con Benedetto Croce che si protrarrà per molti anni. Nel 1909 pubblica il romanzo I vecchi e i giovani e l’anno seguente rappresenta i suoi primi lavori teatrali: La morsa e Lumie di Sicilia.. Nel frattempo continua a scrivere e pubblicare novelle che assumeranno il titolo generale di Novelle per un anno. Il 1915 è uno degli anni più tristi della vita di Pirandello sia per l’entrata in guerra dell’Italia e per il figlio Stefano che parte volontario per il fronte, dove abbastanza presto verrà fatto prigioniero, sia per la morte della madre, verso la quale nutriva un sentimento non solo di amore filiale, ma anche di partecipazione ai suoi intimi segreti dolori, causati da un carattere troppo ‘vivace’ del marito. Col 1916 comincia la vera stagione teatrale pirandelliana con Pensaci, Giacomino! Liolà e La ragione degli altri, alle quali seguiranno Così è, se vi pare (1917), Il berretto a sonagli, Il piacere dell’onestà, La patente, Il giuoco delle parti, Ma non è una cosa seria, Tutto per bene, La Signora Morli uno e due, fino ai Sei personaggi in cerca d’autore, del 1921, opera rappresentata da Dario Niccodemi, scatenando violenti contrasti nel pubblico alla prima ma altrettanti consensi già dalla seconda messa in scena, Enrico IV del 1922, Vestire gli ignudi (1922), Ciascuno a suo modo (1924), ecc.
Nel 1926 pubblica l’ultimo romanzo, Uno nessuno centomila e fonda a Roma, insieme al figlio Stefano, Orio Vergani e Massimo Bontempelli il Teatro d’arte, nel quale debutterà Marta Abba, giovanissima interprete che diverrà musa ispiratrice di alcune commedie, scritte appositamente per lei, con la quale Pirandello stabilirà un rapporto d’affetti che durerà per tutta la vita. Nel 1934 riceve a Stoccolma il premio Nobel per la Letteratura. Muore nel 1936, il 10 dicembre e le sue ceneri verranno tumulate in una roccia nella tenuta del Caos nella quale era nato 68 anni prima, con funerali strettamente privati, come aveva scritto nelle sue ultime volontà.
I quaderni di Serafino Gubbio operatore: il romanzo e il suo contesto storico
I quaderni di Serafino Gubbio operatore sono in numero di sette e scandiscono le pagine di un diario immaginario, scritto a cose già avvenute. Chi scrive è un operatore cinematografico, Serafino Gubbio, soprannominato Si gira, il quale vuole vendicarsi delle macchine che lo hanno ridotto a una mano che gira una manovella, scrivendo, dal suo punto di vista, le vicende della troupe impegnata nella produzione di un film per la casa cinematografica Kosmograph.
Il racconto, in prima persona, si apre con l’arrivo a Roma di Serafino, ospite la prima notte di uno strano tipo di filosofo, Simone Pau, in un ospizio di mendicità. Sono memorie che seguono il percorso di un individuo vittima della macchina da presa, mentre prende coscienza della sua alienazione. Della troupe fanno parte l’attrice Varia Nestoroff, figura esemplare delle nuove dive dello schermo, il regista Nino Polacco, amico intimo di Serafino, e altri attori ed addetti. L’incontro con la Nestoroff riporta alla mente di Serafino momenti del passato: è una donna fatale che ha tragicamente sconvolto la vita felice di due giovani, Giorgio Mirelli, morto suicida, e la sorella Duccella, da lui conosciuti nella paradisiaca “casa dei nonni” vicino a Sorrento. Un’altra vittima è Aldo Nuti, che aveva abbandonato la fidanzata Duccella per seguire la diva. Una storia che si complica nella tragedia finale, raccontata nel settimo quaderno: il film sta per essere terminato, si sta preparando la scena finale dell’uccisione della tigre, feroce e innocente incarnazione della natura. Nella gabbia, dentro la quale è stata ricostruita la giungla, vengono fatti entrare Nuti e Gubbio, l’uno con il fucile, l’altro con la macchina da presa.
Attori e tecnici assistono alla scena finale attorno alla gabbia: appena entra la tigre, “si gira”. Ma ecco che accade l’imprevisto che trasforma la scena di finzione in scena reale: Nuti, anziché colpire la tigre, volge l’arma contro la Nestoroff che sta assistendo alla scena e la uccide, mentre la tigre si avventa su di lui e lentamente lo sbrana. È qui il punto centrale del romanzo: Serafino è talmente alienato dalla macchina che, impassibile come un automa, continua a girare la scena, in una sorta di raggelante identificazione con la macchina. Il sesto romanzo pirandelliano nasce alla vigilia della prima guerra mondiale, nel 1914 e viene pubblicato per la prima volta su di una rivista letteraria, “Nuova Antologia“, e poi in un volume nel 1916 con il titolo “Si Gira“; successivamente, nel 1925, riveduto e corretto appare con un nuovo titolo: “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”. Sono gli anni del Futurismo, che al netto rifiuto della tradizione univa l’esaltazione della vita moderna e dei suoi aspetti più caratteristici: la velocità, le macchine, le nuove metropoli e i complessi industriali. Tali principi vennero elaborati per la prima volta dal poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, che nel Manifesto del futurismo del 1909 sostituiva alla vittoria di Samotracia, quale nuovo ideale estetico, l’immagine della “automobile in corsa con il suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo” mentre, nel 1912 il Manifesto tecnico della letteratura futurista, redatto da Boccioni, Balla, Russolo, Carrà e Severini, era dettato a Marinetti dall’elica turbinante di un aeroplano.
Nell’ambito della situazione politica, culturale ed economica italiana, il futurismo rappresenta quindi la fase più clamorosa della subordinazione della letteratura all’industria capitalista, l’esito estremo delle correnti letterarie spiritualistiche, nazionaliste che presupponevano la negazione dei valori umani: valori che non l’industrializzazione in sé svalorizza ma l’industrializzazione capitalista.
La negazione del passato della storia, l’odio contro ogni forma espressiva tradizionale, il disprezzo della bellezza classica a vantaggio di una nuova bellezza meccanica, sono gli elementi mediante i quali i futuristi intendono negare all’arte ogni diritto di rappresentare l’uomo nelle sue reali aspirazioni individuali e sociali. Il mito della macchina, del progresso meccanico, rappresenta la costante di una letteratura incapace di osservare realisticamente questo progresso nel quadro generale del progresso sociale. Il tema delle fabbriche, delle macchine, dell’elettricità è certamente uno dei prediletti dei futuristi, ma non si tratta solo di una scelta di contenuti: i futuristi affermano, e realizzano, l’antropomorfizzazione della macchina, la vedono in sembianze e le attribuiscono sentimenti umani: la mitragliatrice è paragonata ad una bella donna, poi ad un tribuno, quindi ad un trapano, a un laminatoio, a un tornio elettrico, a un cannello ossidrico.
Ma, d’altra parte, nel futurismo è anche l’uomo a trasformarsi in macchina, sono i suoi sentimenti ad essere espressi con termini presi dalla fraseologia dell’industria: l’uomo ansima come dynamo, i nervi sono paragonati a cavi dell’alta tensione, l’anima grida come un cuore d’acciaio, si protende come un elemento di macchina. Nella struttura e nelle proporzioni del racconto futurista il funzionamento meccanico della nuova civiltà non deve venire intralciato dall’elemento umano; l’uomo non sarà che una rotella nel gigantesco corpo della macchina. E’ il ripudio del neoclassico a favore del moderno. Pirandello invece nutre per le macchine una profonda diffidenza. È proprio sulla insistita polemica vita/macchina che si aprono i Quaderni di Serafino, ridotto dalla sua professione ad essere esclusivamente “una mano che gira una manovella”. L’alienazione di un uomo depauperato di vita e di creatività nel farsi servitore di macchinari è il nucleo intorno a cui ruotano le riflessioni di questo io narrante, più interessato a seguire il suo filo teorico/meditativo che a raccontarci la storia di amore e morte presa a pretesto di narrazione. Siamo, con la prima edizione del romanzo, nel 1915: le macchine che incombono nella nostra vita sono quelle belliche, in una atmosfera pervasa da fremiti futuristi.
Il presagio di Pirandello è quello di una Terra devastata dalla follia distruttiva dell’uomo/macchina e ancor di più, il presentimento che, forse, proprio questo esito apocalittico possa essere l’unica via rigeneratrice dell’essere uomo: “mi domando se veramente tutto questo fragoroso e vertiginoso meccanismo della vita, che di giorno in giorno sempre più si complica e s’accelera, non abbia ridotto l’umanità in tale stato di follia, che presto proromperà frenetica a sconvolgere e a distruggere tutto. Sarebbe forse, in fin dei conti, tanto di guadagnato. Non peraltro, badiamo: per fare una volta tanto punto e a capo”.
Il vertiginoso meccanismo della vita
Le esagerazioni futuriste, se da un lato dimostravano l’assurdità di un riconoscimento entusiastico del progresso industriale dentro una concezione statica anziché dinamica della società, dall’altro attestavano che il mondo meccanizzato non era riducibile a un semplice “contenuto” narrativo o poetico da potersi accettare o scartare a seconda degli interessi dello scrittore, ma una componente essenziale del mondo contemporaneo di fronte alla quale più non reggevano i tradizionali criteri di rappresentazione della realtà. La rivoluzione del linguaggio operata dal futurismo testimonia che lo scrittore è ormai cosciente di vivere in una società che l’industrialismo ha trasformato profondamente. Il tema delle macchine, della velocità, del movimento, tanto caro ai futuristi, diviene quindi, in Pirandello, oggetto di riflessione critica dinanzi al progressivo affermarsi, nella società, di tendenze spersonalizzanti legate all’espandersi della grande industria, nonché al diffondersi delle macchine, che meccanizzano l’esistenza dell’uomo e riducono il singolo a insignificante rotella di un gigantesco meccanismo, privo di relazioni e privo di coscienza.
Un primo effetto di questa spersonalizzante situazione è il mito della velocità, che cresce in tutti gli uomini attirati dalla macchina. All’inizio del terzo quaderno viene presentata un’immagine emblematica: la macchina occupata da tre attrici della Kosmograph che ad alta velocità sorpassa la carrozzella con a bordo Serafino: “Le tre signorine dell’automobile ridono, si voltano, alzano le braccia a salutare con molta vivacità, tra un confuso e gajo svolazzìo di veli variopinti; e la povera carrozzella, avvolta in una nuvola alida, nauseante, di fumo e di polvere, per quanto il cavalluccio sfiancato si sforzi di tirarla col suo trotterello stracco, seguita a dare indietro, indietro, con le case, gli alberi, i rari passanti, finché non scompare in fondo al lungo viale fuor di porta” .
È l’indicazione del mutamento prospettico indotto nell’uomo dalla velocità: le tre donne, ridendo, salutano Serafino, non perché osserva acutamente Pirandello nella carrozzella ci sia qualcuno molto caro a loro; ma perché l’automobile, il meccanismo le inebria e suscita in loro una così sfrenata vivacità. Sembrano quasi prendersi giuoco della carrozzella che, lenta avanza pian pianino, rimasta “indietro comicamente in fondo al viale, fino a scomparire dalla loro vista.” In realtà, in una visione temporale non distorta della vertigine della macchina, non la carrozzella, ma l’automobile è scomparsa: Serafino eccolo là a bordo del suo veicolo. Egli può ammirare “a uno a uno, riposatamente, questi grandi platani verdi del viale, non strappati dalla vostra furia, ma ben piantati qua, che volgono a un soffio d’aria nell’oro del sole tra i bigi rami un fresco d’ombra violacea: giganti della strada, in fila, tanti, aprono e reggono con poderose braccia le immense corone palpitanti al cielo” .
Tale riposata visione della natura non è data alle signorine dell’automobile, le quali possono solo godere di questa e consimili sensazioni di leggiadra vertigine. È il contrasto tra la visione meccanizzata della vita, introdotta dalla seconda rivoluzione industriale, e una concezione più attenta alla situazione umana dei sentimenti. È quella meccanicità che ci porta a vivere caoticamente la nostra esistenza, con il rischio di arrivare alla perdita dei contatti con il nostro essere: “conosco anche io il congegno esterno, vorrei dir meccanico della vita che fragorosamente e vertiginosamente ci affaccenda senza requie. Oggi così e così; questo e quest’ altro da fare; correre qua, con l’orologio alla mano, per essere in tempo là.
Nessuno ha tempo o modo d’arrestarsi un momento a considerare, se quel che vede far agli altri, quel che lui stesso fa, sia veramente ciò che sopra tutto gli convenga, ciò che gli possa dare quella certezza vera, nella quale solamente potrebbe trovar riposo. Il riposo che ci è dato dopo tanto fragore e tanto stordimento, che non ci è più possibile raccoglierci un minuto a pensare”. Secondo Pirandello è la velocità a procurare nello spirito umano un’ansia acuta, che ha la capacità di impadronirsi della nostra mente, causando l’allontanamento dalla vita sociale dell’uomo alienato dalla macchina:
“si va, si vola, e il vento della corsa dà un’ansia vigile ilare e acuta, e si porta via tutti i pensieri. Avanti! Avanti perché non s’abbia tempo ne modo di avvertire il peso della tristezza, l’avvilimento della vergogna, che restano dentro, in fondo. Fuori, è un balenio continuo, uno sbarbaglio incessante: tutto guizza e scompare. Che cosa è? Niente, è passato! Era forse una cosa triste; ma niente, ora è passata. C’è una molestia, però, che non passa, simile a un calabrone che ronza sempre, sembra quasi confondersi con lo striscio continuo della carrucola lungo il filo dei tram elettrici. Il battito del cuore non si avverte, non si avverte il pulsare delle arterie. Guai, se si avvertisse! Ma questo ronzio, questo ticchettio perpetuo della cinepresa, sì, e dice che non è naturale tutta questa furia turbinosa, tutto questo guizzare e scomparire d’immagine; ma che c’è sotto un meccanismo, il quale pare lo insegua stridendo precipitosamente. Ah non bisogna farci l’udito. Darebbe una smania di punto in punto crescente, un’esasperazione a lungo insopportabile; farebbe impazzire. In nulla, più, in mezzo a questo tramenio vertiginoso, che investe e travolge, bisognerebbe fissarsi. Cogliere, attimo per attimo, questo rapido passaggio d’aspetti e di casi, e via, fino al punto che il ronzio per ciascuno di noi non cesserà”.
Il rapporto con la macchina: un’identificazione alienante
L’uomo, ormai schiavo della macchina, appare alienato da se stesso, incapace di esprimere il proprio mondo interiore.
“L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non solo inutile ma anche dannoso, e divenuto saggio e industre, s’è messo a fabbricar di ferro, d’acciaio le sue nuove divinità ed è diventato servo e schiave di esse” . Le macchine succhiano le anime e si nutrono con quelle: “la macchina è fatta per agire, per muoversi, ha bisogno di ingojarsi la nostra anima, di divorare la nostra vita”; le macchine che egli ha creato aspettano voraci che l’uomo le sazi: ma “per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto?”
Questi mostri che dovevano rimanere strumenti sono diventati invece, per forza, i nostri padroni, e le macchine dopo aver ingoiato la nostra vita, ce la restituiscono in produzione centuplicata e continua: “in pezzetti e bocconcini, tutti d’uno stampo, stupidi e precisi, da farne, a metterli su, uno su l’altro, una piramide che non arriverebbe neppure all’altezza d’un palo telegrafico. Un mucchio di scatole, scatolette, scatolone scatoline che un soffio basta per abbattere e rotolare giù rendendole solo ingombro inutile per i nostri piedi che vi inciampano” .
Ecco le produzioni dell’anima nostra, le scatolette della nostra vita. Può venir fuori anche “un bel prodotto e un bel divertimento “ma è una vita in scatola meccanizzata, senza anima: l’anima è stata data in pasto alla macchina. Il romanzo dà la netta sensazione di una crisi interiore; Serafino descrive il conflitto causatogli dall’accettare il ruolo di un automa che deve solamente girare la manovella della cinepresa: “L’anima a me non mi serve. Mi serve la mano; cioè serve alla macchinetta” .
Con sottile ironia Pirandello sottolinea la progressiva spersonalizzazione di Gubbio così come il suo asservimento alla macchina, nella fattispecie la cinepresa. E analogamente, con umorismo amaro osserva:
“Sono operatore. Ma veramente, essere operatore, nel mondo in cui vivo e di cui vivo, non vuol dire mica dire operare. Io non opero nulla”.
Altri tracciano sul tappeto o sulla piattaforma i limiti entro i quali gli attori debbono muoversi per tenere in fuoco la scena, egli non fa altro che prestare i suoi occhi alla macchinetta perché possa indicare fin dove arriva a prendere. Apparecchiata la scena, il direttore vi dispone gli attori e suggerisce loro l’azione da svolgere, dicendo approssimativamente il numero di metri di pellicola che abbisognano, poi grida agli attori: attenti, si gira! E Serafino si mette a girare la manovella, semplice esecutore di ordini che altri hanno dato. Al termine, deve solo indicare quanti metri di pellicola sono stati impiegati. Per fare questo, non occorre aver un’anima; la qualità principale che gli si richiede come operatore è di arrivare ad essere un serio professionista in grado di rimanere impassibile davanti alla vita che lo circonda, puro ingranaggio meccanico, la cui perfezione, in quanto tale, consiste nel raggiungere un totale stato di impassibilità: girando la manovella non può odiare né amare la Nestoroff, come non può odiare né amare nessuno.
Solo alla fine, quando il supplizio d’esser soltanto una mano finisce, egli può riacquistare tutto il suo corpo e riabbandonarsi a quello sciagurato superfluo che è pure in lui e di cui per quasi tutto il giorno la sua professione lo condanna ad esser privo. Quel superfluo che di continuo tormenta inutilmente gli uomini, non facendoli mai paghi di nessuna condizione e sempre lascandoli incerti del loro destino. E tuttavia, sotto la sua maschera di apparente impassibilità, Serafino appare un essere sensibile, mai capace di reprimere completamente le sue emozioni. Come di fronte alla signorina Luisetta, quando, egli sente affiorare in sé dei sentimenti “non necessari” che non gli si addicono in quanto “cosa” ma che, per un momento, valgono a fargli godere della sua ingenuità, del piacere che le cagionava il vento della corsa, mentre gli occhi di Serafino brillavano nel contemplarla.
La totale identificazione con la macchina emerge chiaramente dalle parole di Serafino che afferma “assumo subito, con essa in mano, la mia maschera di impassibilità. Anzi ecco: non sono più. Cammina lei, adesso, con le mie gambe. Da capo a piedi, son cosa sua: faccio parte del suo congegno. La mia testa è qua, nella macchinetta, e me la porto in mano.”
Gubbio scompone la propria figura umana in pezzi confusi e sovrapposti a quelli della macchinetta, arrivando ad affermare che lui non ha più un’anima, perché non gli serve per girare una manovella. Come Serafino è ridotto a “una mano che gira una manovella” così questa umanità anonima e senza volto, divenuta serva delle macchine, coincide tutta ed unicamente con le mani funzionali al lavoro.
È l’immagine che si staglia davanti agli occhi di Serafino e del lettore, nel momento in cui si mette piede nel reparto Artistico o del Negativo, dove si compie misteriosamente l’opera delle macchine, “quanto di vita le macchine hanno mangiato con la voracità delle bestie afflitte da un verme solitario, si rovescia qua, nelle ampie stanze sotterranee, stenebrate appena da cupe lanterne rosse, che alluciano sinistramente d’una lieve tinta sanguinea le enormi bacinelle preparate per il bagno.
La vita ingoiata dalle macchine è li, in quei vermi solitari, dico nelle pellicole già avvolte nei telai. Bisogna fissare questa vita, che non è più vita, perché un’altra macchina possa ridarle movimento qui in tanti attimi sospeso. Siamo come in un ventre, nel quale si stia sviluppando e formando una mostruosa gestazione meccanica.
E quante mani nell’ombra vi lavorano! C’è qui un intero esercito d’uomini e di donne: operatori, tecnici, custodi, addetti alle dinamo e agli altri macchinari, ai prosciugatori, all’imbibizione, ai viraggi, alla coloritura, alla perforatura della pellicola, alla legatura dei pezzi. Basta che io entri qui, in questa oscurità appestata dal fiato delle macchine, dalle esalazioni delle sostanze chimiche, perché tutto il mio superfluo svapori. Mani, non vedo altro che mani, in quelle camere oscure; mani affaccendate su le bacinelle; mani, cui il tetro lucore delle lanterne rosse dà una apparenza spettrale. Penso che queste mani appartengano a uomini che non sono più; che qui sono condannati ad essere mani soltanto: queste mani, strumenti. Hanno un cuore? A che serve? Qua non serve. Solo come strumento anche esso di macchina, può servire, per muovere queste mani.
E così la testa: solo per pensare ciò che a queste mani può servire. E a poco a poco m’invade tutto l’orrore della necessità che mi s’impone, di diventare anch’io una mano e nient ‘altro” . Gubbio subisce dunque un dramma senza alcuna possibile soluzione, intrappolato com’è fra due modi di vita: quello sentimentale e quello meccanico.
Simbolo della sorte miserabile a cui il continuo progresso condanna l’umanità appare un vecchio violinista, incontrato la prima volta da Serafino in un ospizio di mendicità. Erede di una tipografia ben avviata la trascurò fino a ridursi sul lastrico, preso da un’unica passione: il violino.
Malgrado i suoi tentativi di sottrarsi alla tirannia delle macchine, il violinista fu ripetutamente costretto ad accettare umili lavori, come quello di alimentare con forme di piombo le macchine da stampa monotype, in modo da ottenere i soldi per riscattare il suo prezioso strumento dal banco dei pegni.
La tragedia esplode quando una compagnia cinematografica assume il vagabondo per accompagnare una pianola con il suo violino. La richiesta di asservire il suo talento artistico al ritmo automatico di una macchina lo fa infuriare a tal punto da causargli un accesso di ira cieca che gli procura due settimane di prigione.
Rilasciato il vagabondo smette di suonare il suo violino. L’episodio serve da paragone al destino di degradazione provocato da una macchina che il protagonista subisce come operatore. Il violinista entrerà ancora nella vita di Gubbio quando gli verrà proposto di suonare per una tigre che doveva comparire in un film. Alla vista del superbo animale rinchiuso in una gabbia, vittima anch’esso dell’era industriale, il vecchio accetterà di suonare per l’ultima volta.
Poco dopo il vecchi violinista muore, raggiungendo così l’unica liberazione che gli era rimasta, il solo tipo di libertà possibile in un mondo in cui tutti i valori umanistici hanno ceduto il posto alle macchine che divorano l’anima.
La cinepresa come gioco di illusione
Di questo rapporto alienante, uomo-macchina, diventa immagine metaforica la cinepresa. Attraverso di essa Serafino ha l’importante compito di filmare la vanità della vita, la quale assomiglia sempre più ad un film in cui ciascuno interpreta un ruolo sciocco ed insignificante. La cinepresa isola gli attori dalla vita concreta, dal rapporto vivo con il pubblico, che il teatro offriva prima loro, e i fotogrammi che la cinepresa riprende, ritraggono immagini staccate, senza alcun significato. L’ostilità che gli attori nutrono per Gubbio è dovuta alla sottrazione vitale che lui, attraverso la cinepresa, attua su di loro, riducendoli da corpo ad ombra; un’ombra che è destinata ad essere veduta “su uno squallido pezzo di tela” , davanti agli occhi di un pubblico di cui l’attore non si sente più parte viva. Ciascun di essi è li di mala voglia, è li perché pagato meglio, per un lavoro che, se pur gli costa qualche fatica, non gli richiede sforzi di intelligenza.
La macchina, con gli enormi guadagni che produce, può compensarli molto meglio di qualsiasi altro impresario o direttore proprietario di compagnia drammatica. Non solo; ma essa, con le sue riproduzioni meccaniche, riempie le sale dei cinematografi e lascia vuoti i teatri, e gli attori, per non languire, si vedono costretti a picchiare alle porte delle Case di cinematografia. In tal modo si vedono allontanati, strappati dalla comunione diretta col pubblico, da cui prima traevano il miglior compenso e la maggior soddisfazione: quella di vedere, di sentire dal palcoscenico, in un teatro, una moltitudine intenta e sospesa seguire la loro azione viva, commuoversi, fremere, ridere, accendersi, prorompere in applausi. Qua si sentono come in esilio. In esilio non soltanto dal palcoscenico, ma quasi anche da se stessi.
Perché la loro azione, l’azione viva del loro corpo vivo, là, sulla tela dei cinematografi, non c’è più: c’è la loro immagine soltanto, colta in un momento, in un gesto, in una espressione, che guizza e scompare. Avvertono confusamente, con un senso smanioso, indefinibile di vuoto, anzi di vuotamento, che il loro corpo è quasi sottratto, soppresso, privato della sua realtà, del suo respiro, della sua voce, del rumore che esso produce muovendosi, per diventare solamente un’immagine muta, che tremola per un momento sullo schermo e scompare in silenzio, d’un tratto, come un’ombra inconsistente, giuoco d’illusione su uno squallido pezzo di tela. Si sentono schiavi anch’essi di questa macchinetta stridula, che pare un grosso ragno in agguato, un ragno che succhia e assorbe la loro realtà viva per renderla parvenza evanescente, momentanea, giuoco d’illusione meccanica davanti al pubblico. La sera della rappresentazione per essi non viene mai.
Il pubblico non lo vedono più. Pensa la macchinetta alla rappresentazione davanti al pubblico, con le loro ombre; ed essi debbono contentarsi di rappresentare solo davanti a lei. Quando hanno rappresentato, la loro rappresentazione è pellicola.
Il significato dei “Quaderni” nell’opera di Pirandello
Il valore metaforico della cinepresa emerge in tutta la sua profondità se letto alla luce del vitalismo sotteso alla concezione pirandelliana della vita. La realtà tutta è vita, perpetuo movimento vitale, flusso continuo, incandescente, indistinto. Ciò che fuoriesce da questo flusso perde forma, si irrigidisce, comincia a morire. Così avviene per l’identità dell’uomo. La cinepresa, che fissa le azioni in una forma, diviene metafora della inveterata tendenza dell’uomo a fissarsi in una realtà che egli stesso si dà. Il flusso continuo della vita, necessitato a calarsi in forme stabili e determinate, non può, per uguale necessità, consistere in nessuna di esse, ma deve passare di forma in forma e incessantemente, urtandovi contro, infrangere, dissolvere e fluidificare schemi e forme.
È la necessità per la vita di calarsi in una forma ed insieme l’impossibilità di esaurirvisi. Anche gli altri, con cui viviamo in società, vedendoci ciascuno secondo la sua prospettiva particolare, ci impongono determinate forme. Noi crediamo di essere uno per noi stessi e per gli altri, mentre siamo tanti individui diversi, a seconda della visione di chi ci guarda. Ciascuna di queste forme è una visione fittizia, una maschera che noi stessi ci imponiamo e che ci impone il contesto sociale.
La presa di coscienza di questa inconsistenza dell’io suscita nei personaggi pirandelliani smarrimento e dolore. Ancora una volta la metafora della cinepresa appare fortemente significativa e pregnante: le vicende ripresa dalla macchina da presa sono, appunto, finzione, finzione cinematografica, cui manca l’alito genuino della vita. La realtà non è più una totalità organica ma si sfalda in una pluralità di frammenti che non hanno un senso complessivo. Di questa assenza di significato è indice allusivo il nome del protagonista: Serafino. Di lui non abbiamo connotati fisici, ne conosciamo retroterra affettivi, la sua personalità emerge furtivamente in un gioco di specchi, quanto mai sfuggente. L’unica chiave che ci permette di penetrare l’astrattezza del personaggio risiede in quel suo strano nome, Serafino.
Certo non casuale in un autore come Pirandello, convinto che il nome fosse il primo biglietto da visita da affidare al personaggio. La natura del nome e del cognome dell’interprete principale del romanzo è stato oggetto di diverse interpretazioni. Una di queste rimanda a San Francesco, descritto nel paradiso dantesco “serafico in ardore”. Un ulteriore interpretazione si deve a Umberto Artioli il quale notò che “Dottor Seraphicus” era appellativo attribuito a San Bonaventura, autore di un trattato di mistica dal titolo “Itinerarium mentis in Deum” . Il nome del protagonista, dunque, sembra riferirsi allusivamente ad un analogo itinerario interiore, un itinerario, tuttavia, che non va “in Deum”, ma procede verso il nulla, non arriva a nessuna soluzione rigenerativa.
Nell’ “Itinerarium in nihil” pirandelliano l’io si frantuma, si annulla in una serie di frammenti incoerenti. Se per il Romanticismo e il Decadentismo l’interiorità era il centro del reale, sede dell’esperienza originaria dell’Essere, ora questo centro scompare, il soggetto da entità assoluta diviene nessuno. L’umorismo diviene quindi l’arte moderna per eccellenza perché riflette la coscienza di un mondo non più ordinato ma frantumato, in cui non vi sono più prospettive privilegiate e punti di riferimento fissi, ma solo ambiguità e contraddizioni laceranti.
È un’arte critica, che dissolve luoghi comuni e abitudini di pensiero radicale, e costringe a vedere la realtà da prospettive inedite, stranianti, capaci di far saltare comodi e rassicuranti sistemi di certezze. È il continuo contrasto fra la nostra illusione di perfezione e una volontà beffarda che si diverte a farci vedere il rovescio della medaglia, l’altra faccia degli uomini e delle cose deformandole in una smorfia non sai se di riso o di pianto. In questo modo la nostra illusione viene distrutta dall’implacabile apparire del suo contrario. Il contrasto fra l’ideale e il reale, fra l’illusione e la vita, fra la maschera e il volto non è più ancorato a nessuna certezza, ma dà luogo al sentimento dello scacco e dell’impotenza, alimenta una sensazione di casualità, imprevedibilità, relatività delle vicende umane.
Se la realtà è magmatica, in perpetuo divenire, essa non si può fissare in schemi e moduli d’ordine totalizzanti, non esiste una prospettiva privilegiata da cui osservare il reale: al contrario, le prospettive possibili sono infinite e tutte equivalenti.
Ognuno ha la sua verità, che nasce dal suo modo soggettivo di vedere le cose. Ne deriva una desolata incomunicabilità fra gli uomini: essi non possono intendersi perché ognuno fa riferimento alla realtà come è per lui, cristallizzato nella propria solitudine. Un progressivo mutismo avvolge Serafino, escluso dal mondo, disprezzato dai suoi colleghi di lavoro che lo ritengono un “ladro di anime”. Il mutismo di Serafino appare come l’ultima difesa che la sua psiche pone per difendersi dal mondo circostante; un mondo che lo vuole trasformato in un automa senza sentimenti e sprovvisto di un io.
Questo Serafino lo ha capito e cerca in ogni modo di arrivare ad una perfezione di ripresa paragonabile a quella di un automa. Strumento per arrivare a tale perfezione, tra i tanti, è il mutismo, attraverso il quale l’operatore stacca i contatti con gli uomini per rinchiudersi dentro se stesso. La vendetta compiuta da Serafino sul suo ruolo di automa, protraendolo all’estremo, si ritorce, però, contro di lui: lo choc, provocatogli dall’ultima scena del film in cui Nuti prima assasina con un colpo di fucile la Nestoroff e poi si lascia sbranare dalla tigre, lo rende muto per sempre. Per comunicare con gli uomini non gli resta che “una penna e un pezzo di carta”.
L’afasia così raggiunta è, tuttavia, anche la sua perfezione “come operatore”: il suo tanto vantato “silenzio di cosa”, che lo assimila alla macchina fino alla contaminazione fisica con questa, è pervenuto al suo punto culminante.
La parabola è compiuta: quella parabola già prefigurata all’inizio del romanzo dall’incontro emblematico con l’uomo del violino, ridotto anch’egli al mutismo e anch’egli carente di identità, fino alla perdita del nome, sostituito con uno “schifoso” soprannome. Ma tale “professionale impassibilità”, tale afasia, già dalle prime pagine del romanzo è qualcosa da scontare e di cui vendicarsi: “soddisfo, scrivendo, a un bisogno di sfogo, prepotente”. Quasi surrogato della parola viva, di quello scambio di sentimenti e opinioni da cui Serafino è escluso, la scrittura diviene altresì strumento conoscitivo, di analisi, di oggettività non mediata:
“studio la gente nelle sue più ordinate occupazioni, se mi riesca di scoprire negli altri quello che manca a me per ogni cosa ch’io faccia: la certezza che capiscano ciò che fanno” .
Si intravede un bisogno ormai esplicito di conoscenza scientifica, di analisi e rappresentazione, di oggettività non mediata.
Attraverso la scrittura Serafino sembra quasi prolungare quell’estraneità alle trame umane che il suo mestiere gli impone di registrare. Il silenzio dell’operatore, allora, appare non già la trascrizione mimetica, meccanica e naturalistica, di una realtà per altro essa stessa convenzionale e ingannevole, ma la rinunzia a coprire di forme di falsa coscienza la contraddittorietà irreversibile dello spettacolo instante.
Qui il simbolo meccanico della cinepresa segnala nell’impassibilità finale dell’operatore, nella sparizione di ogni ideologia, di ogni ottica narrativa privilegiante, l’ultima e unica possibilità di formalizzazione della realtà, cioè di conoscenza reale, non mistificata, non compromessa.
La rinunzia all’organizzazione ideologica, in tal modo, mette metaforicamente a nudo la crisi di un ruolo ormai insostenibile, falsante e ideologico, quello dello scrittore demiurgo e del suo rapporto con la realtà.
Il processo di disgregazione a cui l’umorismo di Pirandello ha sottoposto tutti i miti – da quelli del realismo ottocentesco a quelli del nuovo storicismo – che i suoi contemporanei si sono creati, giunto alle sue conseguenze ultime, approda al deserto di questo silenzio: alla coscienza dell’impossibilità di pronunciare qualsiasi giudizio sulla vita e sulle umane azioni.
Si ha quindi la scomparsa della mediazione oggettiva, la sparizione dell’autore in quanto portatore di valori e produttore di forme di coscienza della realtà. L’esilio volontario dello scrittore regista, l’assunzione programmatica dell’ottica straniante distante, è dunque una scelta poetica, il segno della singolare consapevolezza del deperimento oggettivo del ruolo dell’intellettuale.
Particolarmente significativa risulta, in questo senso, l’adozione di una figura ricorrente, emblematica: “il forestiere della vita”, colui che ha compreso il giuoco che la società ha intrapreso, e di conseguenza si esclude, si isola, guardando lo scorrere della vita altrui, dall’alto della sua consapevolezza di essere superiore, secondo quella che Pirandello definisce come filosofia del lontano.
Essa consiste nel contemplare la realtà da una infinita distanza, in modo da vedere in una prospettiva straniata tutto ciò che l’abitudine ci fa considerare normale, così da coglierne l’inconsistenza, l’assurdità, la mancanza totale di senso. In questa figura di eroe straniato dalla realtà è possibile rilevare la condizione stessa di Pirandello come intellettuale, che rifiuta il ruolo politico attivo e nel suo pessimismo radicale si riserva solo un ruolo contemplativo, di lucida critica del reale. Ma tale analisi non approda ad una visione totalizzante della realtà: l’unità della natura umana, quel flusso ininterrotto che – sia pure con mille contraddizioni – dovrebbe rappresentare la continuità della nostra persona, non può essere colto nel suo fluire dai nostri mezzi di conoscenza e noi siamo condannati a vederci quasi pietrificati in singoli momenti staccati l’uno dall’altro. Di più: è il regno stesso della vita ad apparire come banalità o angoscia o non senso.
Questa assenza di significato appare evidente anche nella dissoluzione della struttura narrativa, mediante quella che De Castris ha definito la “rivoluzione copernicana” del romanzo: e cioè la formalizzazione dell’impossibilità del tempo oggettivo, continuo, dell’azione storica e della dinamica psicologica convenzionale; in una dialettica di piani che, di fatto, si riduce ad una oggettiva significazione della sua non-rappresentatività: del suo essere forma aperta, inconclusa, di un materiale oggettivo non apprezzabile se non come luogo e occasione di non-conclusione e di relatività, in cui si riversa la casualità degli eventi, il caos delle situazioni, l’allinearsi irrazionale delle forme di coscienza.
La scelta formale di Pirandello è usata come mezzo per attuare una critica alla società borghese, con le sue ideologie e istituzioni, attraverso il suo contribuire attivamente alla crisi della narrativa in funzione di una critica più complessa dei valori, e cioè delle ideologie, che ne fondavano e ne garantivano l’agibilità. Ed è appunto la prospettiva “copernicana” in cui Pirandello colloca il problema del rapporto medesimo tra arte e realtà, tra falsa assolutezza del soggetto e delle forme fenomeniche dell’esistenza: una prospettiva che non tanto misura la degradazione oggettiva dei rapporti sociali e degli istituti dell’ordine borghese, quanto la falsità dei valori, delle forme di ricomposizione ideologica della crisi, delle certezze logiche ed etiche tuttora operanti come strumento di violenza e di sfruttamento.
Leggi anche Luigi Pirandello: vita, personalità e tematiche