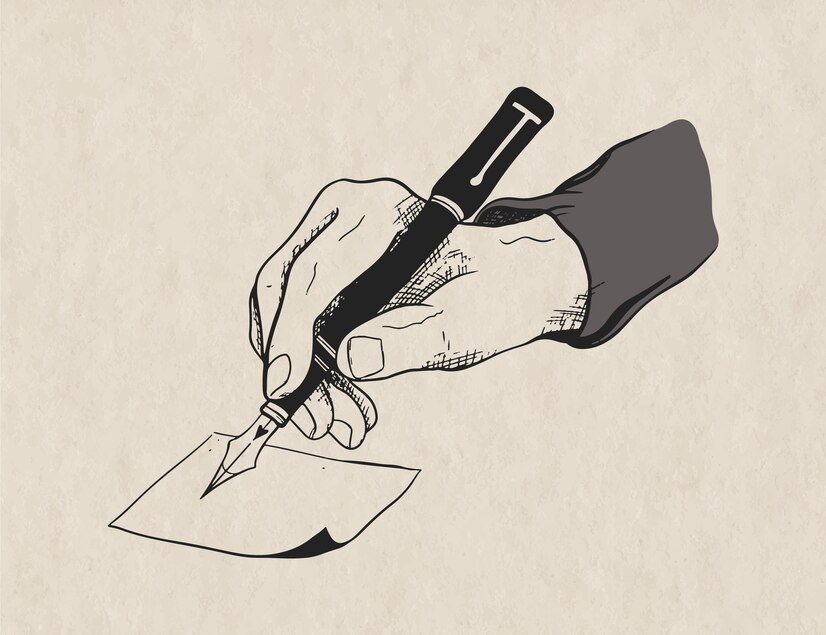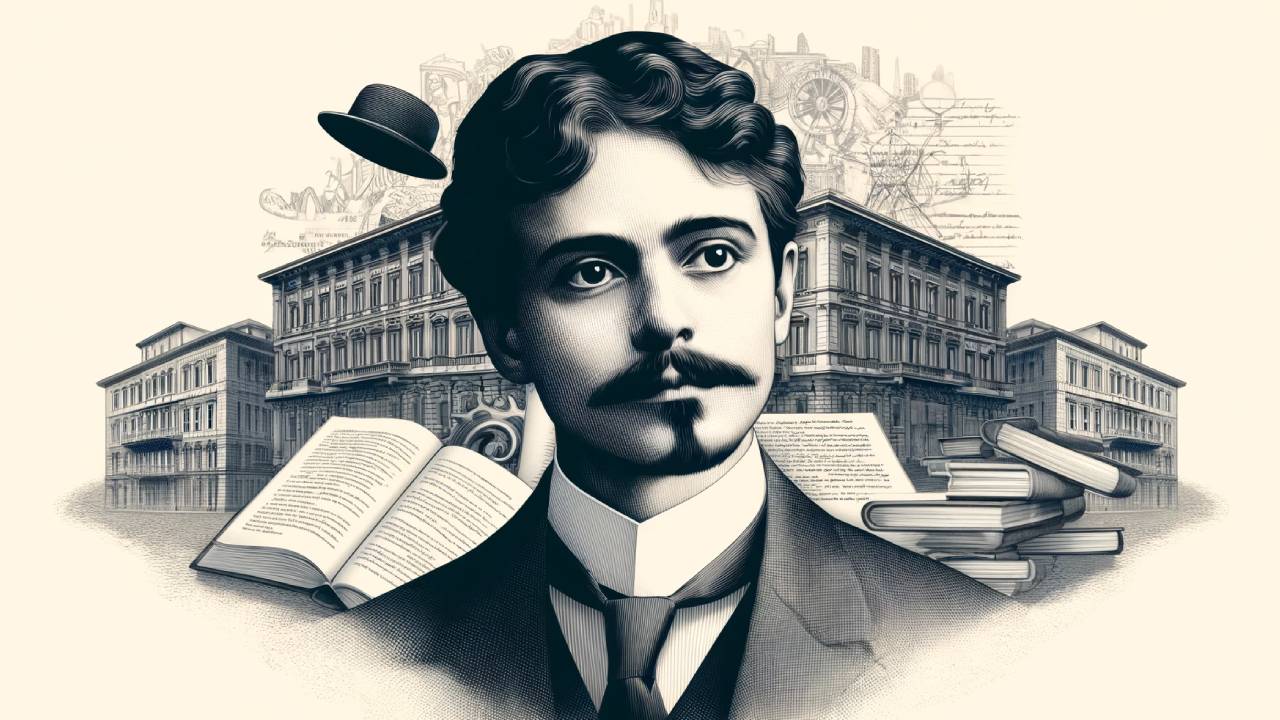La storia di Ignazio Silone è quella di un uomo che ha vissuto tra rivoluzioni, fughe e scrittura, sempre fedele ai suoi ideali di giustizia e libertà, anche nelle sue opere. Conosciamo la sua vita e due dei suoi romanzi più famosi: Fontamara e L’avventura di un povero cristiano.
L’incredibile vita di Ignazio Silone tra lotta politica e scrittura
Un’infanzia segnata dalla tragedia
Ignazio Silone nasce nel 1900 in una modesta famiglia della Marsica. La sua infanzia dura poco: dopo la morte del padre nel 1911, la situazione economica della famiglia peggiora a tal punto da costringerlo ad abbandonare gli studi. Ma la vera tragedia arriva nel 1915, quando un devastante terremoto distrugge la sua terra e gli porta via quasi tutta la famiglia: sopravvive solo il fratello minore, Romolo. Questo dramma lo segna profondamente e torna spesso nei suoi scritti.
L’incontro che gli cambia la vita
Dopo la catastrofe, i due fratelli vengono accolti in diversi istituti religiosi. A Sanremo, Silone incontra don Luigi Orione, un sacerdote che nota subito il suo talento e decide di guidarlo negli studi: in questo periodo Silone si avvicina all’istruzione e alla cultura, gettando le basi per la sua futura carriera di politico e scrittore.
Le prime battaglie politiche
Silone non dimentica le difficoltà della sua gente: ogni volta che torna a Pescina, vede i contadini lottare contro ingiustizie e povertà e questo lo motiva a entrare in politica. Nel 1917 aderisce alla Lega dei Contadini e, due anni dopo, si iscrive al Partito Socialista, attirato dalle idee della Rivoluzione d’Ottobre che sta scuotendo il mondo.
Da rivoluzionario a dissidente
Silone sostiene la linea comunista di Gramsci e Bordiga, contribuendo alla nascita del Partito Comunista d’Italia nel 1921 fino a diventarne uno dei maggiori esponenti. La sua importanza lo porta fino a Mosca come delegato: lì incontra Lenin e Trotzkij, ma non condivide la rigidità ideologica del partito sovietico e inizia a dubitare della sua fedeltà assoluta ai dogmi del comunismo.
In fuga dal fascismo
Mentre il fascismo prende il controllo dell’Italia, Silone e gli altri leader comunisti sono costretti a spostarsi per evitare la repressione. Nel 1926, dopo le leggi repressive di Mussolini che rendono impossibile l’attività politica, si rifugia in Svizzera. Nel frattempo, dopo la morte di Lenin, la situazione nel partito cambia: Stalin impone una linea dura ma Silone si oppone tanto che, nel 1930, viene espulso dal partito.
Nasce uno scrittore
Solo e politicamente isolato, Silone attraversa un momento difficile, durante il quale scopre la sua vocazione letteraria. In pochi mesi scrive “Fontamara”, il suo capolavoro, che racconta la vita dura dei contadini abruzzesi, e negli anni successivi pubblica “Il fascismo. Origini e sviluppo” (1934), la raccolta “Un viaggio a Parigi” (1935) e il romanzo “Vino e pane” (1936). Il suo talento non passa inosservato e scrittori come Thomas Mann e Bertolt Brecht iniziano a considerarlo una delle voci più potenti della sua epoca.
La distanza dal marxismo e la riscoperta del cristianesimo
Nel 1941, con la pubblicazione de Il seme sotto la neve, Silone prende definitivamente le distanze dal marxismo, criticandone le derive dogmatiche e autoritarie. Inizia così un percorso di riscoperta degli ideali cristiani e della disobbedienza civile, tematiche che influenzeranno profondamente la sua produzione successiva.
Il ritorno in Italia e il successo letterario
Dopo anni di esilio, nel 1944 torna in Italia, accolto dal leader socialista Pietro Nenni ma, sebbene si riavvicini alla politica, la sua principale attività rimane la scrittura. Nel 1949, Fontamara viene finalmente pubblicato in Italia e riceve ampi riconoscimenti; nel 1952 esce anche Una manciata di more, opera fortemente critica che divide la stampa e provoca una dura reazione dei giornali comunisti.
Diventato un intellettuale di spicco, nel 1954 presiede la giuria della Mostra del Cinema di Venezia. Seguono altri romanzi di successo come Il segreto di Luca (1956), La volpe e le camelie (1960) e Uscita di sicurezza (1965), che lo consacrano definitivamente come una delle voci più importanti della letteratura italiana del Novecento.
La riflessione sul cristianesimo e gli ultimi anni
Nel 1968 pubblica L’avventura di un povero cristiano, romanzo che ripercorre la vita di Celestino V e che rappresenta il culmine della sua riflessione sul cristianesimo autentico, contrapposto alle gerarchie ecclesiastiche. Durante gli anni ’70 la sua salute peggiora progressivamente, fino alla morte nel 1978.
Dopo la sua scomparsa, nel 1981 viene pubblicato postumo Severina, il suo ultimo romanzo. La sua eredità letteraria e intellettuale rimane ancora oggi un punto di riferimento per chi ricerca una letteratura impegnata, capace di coniugare riflessione politica e tensione etica.
I romanzi più famosi di Ignazio Silone
Fontamara
Il primo romanzo di Ignazio Silone non è solo una storia, ma un manifesto di denuncia contro le ingiustizie sociali e la brutalità del regime fascista. Ambientato nel 1929 in un immaginario borgo abruzzese chiamato Fontamara, il libro racconta la lotta disperata di una comunità di contadini schiacciata dai soprusi dei potenti: le disuguaglianze e l’abuso di potere sono al centro della narrazione, riflettendo il forte impegno politico e sociale dell’autore.
La storia ha inizio con una decisione crudele: le autorità staccano la corrente elettrica a Fontamara, lasciando gli abitanti nel buio più totale; i contadini, troppo poveri per pagare le bollette, si trovano così privati di un servizio essenziale, ma questo sarà solo l’inizio di una serie di ingiustizie che li colpiranno duramente.
A promettere una soluzione arriva il cavaliere Pelino, uomo vicino al Partito Nazionale Fascista e nuovo podestà del paese. Con fare rassicurante, convince gli abitanti a firmare un documento in bianco, assicurando che così riavranno l’elettricità. Ma il contratto nasconde un inganno: con quella firma, i contadini cedono inconsapevolmente i diritti sull’acqua del loro torrente a un ricco latifondista, condannando le loro terre alla siccità.
Quando gli abitanti di Fontamara si rendono conto della truffa, tentano di far valere le proprie ragioni affidandosi a un avvocato, don Circostanza, che però si rivela complice dei potenti. Le proteste vengono brutalmente represse: Pelino chiama in aiuto una squadra di camicie nere, che si abbatte sul paese con violenza inaudita, umiliando le donne e schedando gli uomini come sovversivi.
Uno dei protagonisti, Berardo Viola, decide di lasciare il paese nella speranza di trovare lavoro altrove ma, essendo stato segnalato dal regime, nessuno vuole assumerlo; Viola continua così a vagabondare, finché incontra un uomo noto come l’Avezzanese, un oppositore del fascismo che lo introduce alla lotta politica.
Berardo e l’Avezzanese vengono arrestati per errore. In prigione, Berardo acquisisce piena consapevolezza dell’oppressione subita dalla sua gente e decide di compiere un gesto estremo: per proteggere i compagni, si autodenuncia fingendosi un noto resistente antifascista. Questa scelta coraggiosa gli costa la vita, ma fa di lui un simbolo di ribellione.
A Fontamara, i suoi compaesani non dimenticano il suo sacrificio. Per dare voce alla loro disperazione, fondano il giornale clandestino “Che fare?”, dove denunciano le loro condizioni di miseria e l’ingiusta morte di Berardo. Ma la reazione del regime è spietata: le squadracce fasciste tornano ad attaccare il paese, sterminando gran parte della popolazione. Alla fine, restano solo tre sopravvissuti a raccontare la tragedia.
Nel romanzo emergono chiaramente i ricordi dell’infanzia di Silone e le ingiustizie vissute nella sua terra natale. Il dolore del terremoto che distrusse la Marsica, la povertà dei contadini, l’oppressione dei potenti e la sua esperienza politica si intrecciano nella narrazione, rendendo “Fontamara” non solo un’opera letteraria, ma anche una testimonianza di resistenza e dignità.
L’avventura di un povero cristiano
L’avventura di un povero cristiano è l’ultima opera di Ignazio Silone e, senza dubbio, una delle più profonde e complesse. Il romanzo prende il via con un’introduzione articolata in quattro capitoli, dove l’autore si mette sulle tracce di Pietro Angelerio, il futuro Celestino V. Questo viaggio nella storia è anche un ritorno ai luoghi dell’Abruzzo e a una dimensione più intima, dove Silone esplora una spiritualità post-marxista e un cristianesimo lontano dalle istituzioni ufficiali.
La seconda parte si trasforma in un vero e proprio dramma teatrale, mettendo in scena il contrasto tra la Chiesa istituzionale e un approccio religioso più autentico, basato sulla compassione e sulla povertà. Qui il protagonista, Pietro Angelerio, diventa il simbolo di un cristianesimo vissuto con umiltà, incarnato non solo dai contadini abruzzesi, ma anche dai frati mendicanti seguaci di San Francesco. Suo malgrado, viene scelto come papa dalla curia romana, ma il peso del potere gli è insopportabile e dopo pochi mesi rinuncia al pontificato.
Nel dramma emerge la figura di Benedetto Caetani, il futuro Bonifacio VIII, che incarna tutto ciò che Celestino rifiuta: la Chiesa come istituzione politica, lontana dalla sua missione spirituale. Caetani è il grande antagonista della storia, spietato e determinato a eliminare ogni ostacolo ai suoi piani di potere.
Con questo romanzo, Silone esprime il punto d’arrivo della sua evoluzione intellettuale. Dopo aver abbandonato il marxismo, abbraccia un cristianesimo che si identifica con gli ultimi, con gli emarginati, e che rifiuta la gerarchia ecclesiastica. Il suo Celestino V è il simbolo di una fede pura, opposta a qualsiasi logica di potere.
Vedi anche:
- Scheda libro: Il fu Mattia Pascal
- Italo Svevo: biografia e romanzi dell’autore
- Maturità 2025: tutto quello che devi sapere
- Collegamenti Interdisciplinari Maturità: argomenti ed esempi per l’orale
- Possibili tracce maturità 2025: tutti gli anniversari
- Maturità: traccia sugli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale