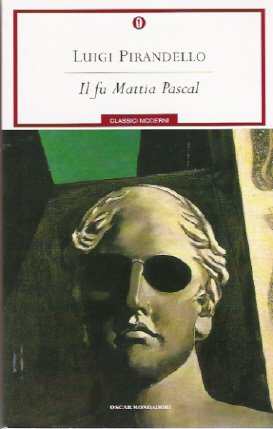Il comico secondo Bergson
1. Le fonti. Le riflessioni di Bergson sulla natura della comicità sono racchiuse in un breve libro, intitolato Il riso. Saggio sul significato del comico (1900), destinato ad un successo travolgente: ebbe infatti più di sessanta edizioni in poco più di quarant’anni, grazie anche alla leggerezza dello stile che rende tanto più piacevolmente leggibile un’opera che ò peraltro assai più impegnativa e ricca di quanto non sembri. Quest’opera si situa in una fase importante dell’evoluzione del pensiero bergsoniano: si colloca infatti negli anni in cui da interessi prevalentemente psicologico-filosofici Bergson muove verso una filosofia della vita orientata metafisicamente.
Il saggio sul riso accomuna dunque, come vedremo, queste due tendenze della speculazione di Bergson e rappresenta quindi una possibile introduzione al suo pensiero.
2. Un’idea antica: il riso ha una funzione sociale. Nelle pagine di questo suo libro, Bergson muove innanzitutto da una constatazione di natura generale: se il riso ò un gesto che appartiene a pieno titolo al comportamento umano, allora deve essere lecito domandarsi qual ò il fine che lo anima. Ora, per comprendere il fine cui mira un comportamento si deve in primo luogo far luce sulle occasioni in cui accade. E per Bergson vi sono almeno tre punti che debbono essere a questo proposito sottolineati: “Non vi ò nulla di comico al di fuori di ciò che ò propriamente umano” (ivi, p. 4). Questa affermazione può lasciarci di primo acchito perplessi: si può ridere infatti anche di un cappello o di un burattino di legno. E tuttavia, se non ci si ferma a questa constatazione in sé ovvia, si deve riconoscere che in questi casi il rimando a ciò che ò umano gioca un ruolo prevalente e comunque ineliminabile: di un cappello ridiamo perché vi vediamo espresso un qualche capriccio estetico dell’uomo, così come nella marionetta l’immaginazione scorge i gesti impacciati di un uomo sgraziato. Alla massima antica secondo la quale l’uomo è l’animale che ride si deve affiancarne dunque una moderna: l’uomo è un animale che fa ridere.
Il riso scaturisce solo di fronte a ciò che appartiene direttamente o indirettamente all’ambito propriamente umano; perché possa tuttavia scaturire ò necessario che chi ride non si lasci coinvolgere emotivamente dalla scena che lo diverte. Per ridere di una piccola disgrazia altrui dobbiamo far tacere per un attimo la pietà e la simpatia, e porci come semplici spettatori o – per esprimerci come Bergson – come intelligenze pure: “il comico esige dunque, per produrre tutto il suo effetto, qualcosa come un’anestesia momentanea del cuore” (ivi, pp. 5-6). Il riso – abbiamo osservato – chiede una sorta di sospensione del legame di simpatia che ci lega a colui di cui ridiamo. E tuttavia tutti sappiamo che il riso è un’esperienza corale: ridiamo meglio quando siamo insieme ad altri, ed il riso è spesso il cemento che tiene unito un gruppo di persone.
“Il riso, – commenta Bergson – [… ] cela sempre un pensiero nascosto di intesa, direi quasi di complicità , con altre persone che ridono, reali o immaginarie che siano” (ivi, p. 6). Non ò difficile scorgere la nota che accomuna queste tre osservazioni generali: il riso sembra essere strettamente connesso con la vita sociale dell’uomo, con il suo essere un animale sociale. Possiamo allora – seguendo Bergson – far convergere i tre punti su cui abbiamo dianzi richiamato l’attenzione in un’unica tesi, che getta appunto la sua luce sul quando del riso: “Il “comico” nasce quando uomini riuniti in un gruppo dirigono l’attenzione su uno di loro, facendo tacere la loro sensibilità , ed esercitando solo la loro intelligenza” (ivi, p. 7). E se le cose stanno così, se il riso come comportamento umano sorge nella vita associata, allora si può supporre che esso risponda a determinate esigenze della vita sociale.
3. Il riso ed il diavolo a molla. Per far luce sul motivo che ci spinge a ridere non basta indicare quando ridiamo: occorre riflettere anche su ciò di cui ridiamo. Orientarsi in questa seconda parte delle analisi vuol dire innanzitutto lasciarsi guidare dagli esempi, e tra questi uno gode di una posizione privilegiata proprio per la sua estrema semplicità : il gioco del diavolo a molla. “Noi tutti abbiamo giocato [… ] col diavolo che esce dalla sua scatola. Lo si schiaccia ed ecco si raddrizza; lo si ricaccia più in basso ed esso rimbalza più in alto, lo si scaccia sotto il coperchio ed esso fa saltare tutto” (p. 46) scrive Bergson, e propone subito dopo un’osservazione che ci spiega perchè un simile gioco possa far ridere un bambino: “E’ il conflitto di due ostinazioni, di cui l’una puramente meccanica finisce ordinariamente per cedere all’altra, che se ne prende gioco” (ivi, p. 47). Del diavolo ci fa ridere la cieca ostinazione, il suo “saltar su” come una molla: è dunque il comportamento rigidamente meccanico di ciò che pure nel gioco vale come un essere dotato di un’autonoma volontà a far ridere il bambino. Un comportamento rigidamente meccanico applicato a ciò che ò (o immaginiamo che sia) vivente: su questa tesi dobbiamo riflettere perché per Bergson circoscrive in modo sufficientemente preciso l’ambito del comico.
Molti esempi di comicità possono esserle immediatamente ricondotti: una marionetta ci fa ridere perché i suoi gesti sono rigidi e meccanici, ed ò per questa stessa ragione che ci sembra ridicolo chi – giunto in fondo alle scale – tenta di scendere anche da un ultimo inesistente gradino, con un gesto goffo che non ò motivato da un fine reale, ma solo dal meccanismo acquisito della discesa. Altri invece ci costringono a disporci nella prospettiva propria dell’immaginazione che con le definizioni non procede con la stessa metodica precisione dell’intelletto: così, non dobbiamo stupirci se il topos della meccanicità si estende per l’immaginazione fino a coprire campi che non sembrano in senso stretto spettarle.
Per l’immaginazione una macchina è innanzitutto ripetitiva: di qui la comicità che sorge dalla ripetizione dei gesti, delle azioni, dei pensieri. “Due volti simili, ciascuno dei quali preso isolatamente non fa ridere, presi insieme fanno ridere per la loro somiglianza” – diceva Pascal, e tutti sappiamo come un tic fisico o intellettuale (una frase, sempre la stessa, ripetuta troppo di sovente) sia causa di ilarità . Ma un meccanismo non è solo ripetizione: ò anche – a dispetto del movimento – staticità . Una macchina è inchiodata alla sua funzione: così, chi voglia fare una caricatura, saprà farci ridere solo a patto di ritrarre nel volto una piega espressiva solidificata in un tratto stabile della fisionomia, un’espressione cui la macchina dei lineamenti non sa più sottrarsi. Nell’immagine della macchina si cela infine anche l’idea dell’ostinazione cieca, del movimento che non sa più aderire al presente, ma segue una regola tanto fissa quanto sorda alle esigenze del momento. Basta dunque che questa immagine si sovrapponga alla vita umana perchè il riso si faccia avanti. Una simile sovrapposizione si ha per esempio quando l’anima ci si mostrerà contrariata dai bisogni del corpo – da un lato la personalità morale con la sua energia intelligentemente variata, dall’altra il corpo stupidamente monotono interrompente sempre ogni cosa con la sua esigenza di macchina.
Quanto più queste esigenze del corpo saranno meschine ed uniformemente ripetute, tanto più l’effetto sarà vivo (ivi, p. 33). Non ò dunque un caso – commenta Bergson – se i personaggi tragici debbono tenersi lontani da gesti che tradiscano le esigenze della corporeità, mentre il commediografo potrà senz’altro ottenere il riso del pubblico rappresentando i suoi personaggi comici in preda a un malanno o ad un fastidioso singhiozzo che interrompe ogni loro discorso. Proprio come la vita dello spirito può essere ostacolata nel suo realizzarsi dalle esigenze della macchina corporea, così la forma della vita sociale può soffocarne il senso. La lettera – le regole e le convenzioni sociali – si sovrappone alla sostanza – la vita in comune, e dalla contemplazione di questo travestimento della vita sorge la comicità: il deputato che interpellando il ministro su di un assassinio famoso rammenta che il colpevole, dopo aver ucciso la vittima, è sceso dal treno in senso contrario alla sua direzione, violando così il regolamento, è – per Bergson – comico perché in lui l’adesione alla regola ha soffocato la comprensione della vita. Potremo soffermarci ancora sulle strade che l’immaginazione comica percorre, e non sarebbe difficile mostrare come a partire dalle poche cose che abbiamo detto possano comprendersi le ragioni che ci spingono a ridere dei travestimenti o – e su questo punto dovremo in seguito ritornare – dei vizi di natura morale.
Per ora ci basta invece il risultato cui siamo pervenuti: ciò di cui ridiamo ò – per Bergson – tutto ciò in cui l’immaginazione scorge una sorta di meccanicizzazione della vita.
4. Il riso come castigo sociale. La comicità morale e la funzione sociale della commedia. Le considerazioni che abbiamo sin qui svolto ci permettono di formulare ora, senza ulteriori indugi, una risposta alla domanda da cui avevamo preso le mosse, – la domanda sul fine che il riso persegue. Il riso – avevamo osservato – deve avere una funzione sociale, e sorge – aggiungiamo ora – dalla constatazione di una sorta di contraddizione: ciò che dovrebbe comportarsi in modo libero e vivo sembra assoggettare i suoi gesti a leggi meccaniche, alla cieca ostinazione del meccanismo. Al riso spetta dunque il compito di sanare questa contraddizione, richiamando quella parte della società (reale o immaginaria) che ò colpevole di un comportamento rigido e ostinato ad un atteggiamento più elastico, ad uno stile di vita più duttile e desto.
Il riso ò quindi un castigo sociale: è comico – scrive Bergson – qualunque individuo che segua automaticamente il suo cammino senza darsi pensiero di prendere contatto con gli altri. Il riso è là per correggere la sua distrazione e per svegliarlo dal suo sogno. [… ]. Tutte le piccole società che si formano sulla grande sono portate, per un vago istinto, ad inventare una moda per correggere e per addolcire la rigidità delle abitudini contratte altrove, e che sono da modificare. La Società propriamente detta non procede diversamente: bisogna che ciascuno dei suoi membri stia attento a ciò che gli è intorno, si modelli su quello che lo circonda, eviti infine di rinchiudersi nel suo carattere come in una torre di avorio. Perciò essa fa dominare su ciascuno, se non la minaccia di una correzione, per lo meno la prospettiva di un’umiliazione che per quanto leggera non ò meno temibile.
Tale si presenta la funzione del riso. Sempre un po’ umiliante per chi ne ò l’oggetto, il riso ò veramente una specie di castigo sociale (ivi, pp. 88-9). Di questa funzione sociale del riso, la commedia è per Bergson un’espressione esemplare. Tra tutte le forme di comicità una in particolare sembra stringere un rapporto strettissimo con la sfera sociale: è la comicità morale. Le passioni spesso si prendono gioco di noi e subordinano tutte le nostre azioni ad un unico meccanismo. E’ questo ciò che accade ai personaggi comici di molte commedie: lo spettatore è chiamato a ridere di un uomo, i cui gesti sembrano quelli di una marionetta, mossa da un burattinaio – la gelosia, l’avarizia, la pavidità , ecc. – che ci ò ben noto e di cui sappiamo prevedere i movimenti. Di qui la forma di tante commedie che hanno per protagonisti non già individualità ben determinate, ma personaggi tipici, marionette dietro alle quali traspare la passione che li domina. Ma di qui anche il fine che si prefiggono: correggere, ridendo, i costumi.
Alle forme propriamente artistiche, caratterizzate dall’assoluta assenza di finalità pratiche si deve contrapporre dunque la commedia, che ò – per Bergson – una forma artistica spuria, proprio perché affonda le sue radici nella vita e perché alla vita ritorna come ad un valore da salvaguardare e cui sottomettere i propri sforzi. Vi ò tuttavia una seconda ragione che spinge Bergson a dedicare tanto spazio alle considerazioni sulla commedia, ed ò propriamente il carattere per così dire teatrale della comicità . Possiamo ridere soltanto quando la rigidità di un carattere o di un comportamento si fa gesto e si mostra apertamente agli occhi dell’immaginazione: non ci basta sapere che la paura della morte ha trasformato Argan in un burattino; per ridere dobbiamo vedere i gesti in cui la riduzione dell’uomo a cosa si fa spettacolo.
Ma lo spettacolo comico implica uno spettatore che sappia per un attimo guardare alla vita come ad una rappresentazione teatrale: da ciò il carattere equivoco del comico. Esso non appartiene nè completamente all’arte, nè completamente alla vita. Da un lato i personaggi della vita reale non ci farebbero mai ridere se noi non fossimo capaci di assistere alle loro vicende come ad uno spettacolo visto dall’alto di una loggia; essi sono comici ai nostri occhi solo perchè ci danno la commedia. Ma d’altra parte, anche a teatro, il piacere di ridere non ò puro, cioò esclusivamente estetico, assolutamente disinteressato. Vi si associa sempre un pensiero occulto che la società ha per noi quando non l’abbiamo noi stessi; vi ò sempre l’intenzione non confessata di umiliare e con ciò, ò vero, di correggere, almeno esteriormente” (ivi, p. 89).
Il riso sorge così come un gesto che per strappare la vita dalla sua negazione implica una momentanea sospensione della vita stessa: è dunque una contemplazione della vita volta a sanare i pericoli che la mettono in forse.
5. Il riso e la metafisica bergsoniana. Nonostante la sua indubbia coerenza e la sua capacità di far luce su di un aspetto importante del comico, il saggio di Bergson sembra lasciare aperto più di un problema. Ciò che in particolare colpisce il lettore ò forse il trovarsi di fronte ad un saggio che con tanto vigore sottolinea la funzione sociale del riso, senza tuttavia sfociare in un’indagine di natura sociologica che – tra le altre cose – ci mostri quali sono i processi di apprendimento del riso.
Perché almeno questo ò chiaro: se il riso ò un gesto sociale che appartiene alla forma di vita propria dell’uomo, allora deve esistere qualcosa come un addestramento al riso, – un addestramento che insegni al bambino quali sono i vizi e i difetti di cui ridere e quando è opportuno riderne. In realtà , basta dare uno sguardo alle brevi considerazioni che Bergson raccoglie intorno a questi problemi per rendersi conto che le sue analisi si muovono in un’altra direzione. Se con Bergson indichiamo quali siano i “difetti” censurati dal riso siamo innanzitutto ricondotti a ciò che ci rende non tanto immorali, quanto poco adatti alla società , ma dobbiamo poi – in secondo luogo – rammentare che troviamo comiche anche le fisionomie buffe nelle quali l’immaginazione può scorgere un irrigidimento della vita espressiva, ma in cui sarebbe insensato scorgere un problema per la società . Se il riso è un castigo sociale, allora si deve aggiungere che talvolta sembra castigare anche là dove non ce n’ò alcun bisogno.
Non solo: di un vizio morale come l’avarizia o la gelosia, noi non sempre ridiamo, poichè – osserva in primo luogo Bergson – il riso chiede che il vizio da castigare non ci coinvolga troppo da vicino e ci permetta di mantenere la posizione dello spettatore. In secondo luogo, tuttavia, Bergson attira la nostra attenzione sul fatto che uno stesso vizio – l’avarizia, per esempio – può talvolta suscitare il riso, talvolta il nostro disprezzo. Ora, la diversità della reazione non dipende solo dalla gravità della colpa, ma soprattutto dal modo in cui questa si palesa. E ancora una volta il cammino da seguire ci è indicato dall’esperienza letteraria. Gli eroi tragici ci rivelano il loro carattere nelle azioni, e con azioni Bergson intende i comportamenti volontari della soggettività . Il personaggio comico invece si rivela nei gesti, e cioò in quei movimenti e in quei discorsi nei quali uno stato d’animo si manifesta senza scopo e senza alcuna premeditazione. Nell’azione la persona intera ò in gioco, nel gesto una parte isolata della persona si esprime all’insaputa o (per lo meno) in disparte dell’intera personalità (ivi, p. 94).
Il gesto – potremmo allora esprimerci così – ò una sorta di irruzione improvvisa dell’inconscio nella vita desta, ed ò proprio questo carattere di involontarietà e di immediatezza che ci fa apparire comico anche un vizio che detestiamo. Ma se il comico si esprime nel gesto, anche il riso ò a sua volta un gesto sociale (ivi, p. 14) di cui si deve sottolineare l’immediatezza: non bisogna dunque stupirsi se non ha tempo di osservare sempre dove tocca [… e se] talvolta castiga certi difetti come la malattia castiga certi eccessi, colpendo gli innocenti, risparmiando i colpevoli, mirando verso un risultato generale, senza preoccuparsi del singolo” (ivi, p. 126). Così, accanto alla tesi secondo la quale il riso sorge come prodotto di un’antica abitudine sociale, Bergson viene sempre più chiaramente sostenendo che “il riso ò semplicemente l’effetto di un meccanismo datoci dalla natura” (ivi, p. 126).
Ed in questa prospettiva, il problema di un addestramento al riso non si pone, poiché il riso ci appare come una manifestazione diretta della natura, come una difesa immediata della vita che è la vita stessa a donarci, armandoci di una sorta di istintiva reazione alla comicità . Se dunque Bergson non si impegna sul terreno delle considerazioni sociologiche ò proprio perchè intende rispondere alla domanda sulle origini del riso sul terreno di una autentica metafisica della vita, che del resto si fa percepire in vari passaggi del saggio bergsoniano. La nostra immaginazione – scrive Bergson – ha una sua filosofia ben salda; in tutte le forme umane essa scorge lo sforzo di un’anima che foggia la materia, anima infinitamente agile, eternamente mobile sottratta al peso perchè non ò la terra che l’attira… Con la sua leggerezza alata quest’anima comunica qualcosa al corpo che anima: l’immaterialità che passa così nella materia ò ciò che si chiama grazia. Ma la materia resiste e si ostina. Essa attira, e vorrebbe convertire la propria inerzia e fare degenerare in automatismo l’attività sempre sveglia di questo principio superiore [… ]. Laddove la materia riesce a far crassa esteriormente la vita dell’anima, irrigidendone il movimento ed ostacolandone la grazia, ottiene dal corpo un effetto comico (ivi, pp. 19-20). Non ò difficile scorgere in queste pagine (o in quelle in cui si deducono le leggi della comicità dalla diretta negazione della nozione metafisica di vita) il germe di quella filosofia che troverà poi nell’Evoluzione creatrice la sua configurazione definitiva. La lotta tra l’urgere dinamico e multiforme della vita e la resistenza cieca e sorda che la materia le impone trova già qui, nella disamina sul comico, la sua prefigurazione. Così, non ci si deve stupire se l’abitudine al riso à tanto antica da affondare le sue radici in un meccanismo della natura (ivi, p. 126): il riso ò sì un castigo sociale, ma le sue origini non appartengono alla società , ma alla vita stessa e debbono essere quindi viste sullo sfondo della lotta tra lo slancio vitale e l’inerzia della materia. E se ci si pone in questa prospettiva, le considerazioni bergsoniane vengono a collocarsi nell’orizzonte problematico di una filosofia della vita, – un orizzonte cui già alludevano le pagine di Schopenhauer.
L’umorismo secondo Pirandello
1. Le fonti. Al nome di Pirandello si lega innanzitutto un’ampia produzione letteraria che abbraccia opere di teatro, racconti e romanzi, e che fa del suo autore una delle figure più significative del panorama della letteratura europea del Novecento. Tuttavia, accanto al Pirandello letterato, vi ò anche un Pirandello saggista che approfondisce con gli strumenti della critica e della riflessione filosofica alcuni temi della sua opera letteraria. E’ in questa luce che si colloca L’umorismo, un saggio pubblicato nel 1908 che raccoglie parzialmente le lezioni tenute da Pirandello all’Istituto Superiore di Magistero di Roma e che si divide n due parti ben distinte: una di carattere storico-letterario, l’altra di natura filosofica. Il libro ò dedicato alla memoria della buon anima di Fu Mattia Pascal bibliotecario: il Pirandello filosofo si riconnette così al Pirandello letterato, impedendoci di tracciare un confine troppo netto tra gli ambiti della sua produzione.
2. L’essenza dell’umorismo. Tra le prime reazioni al saggio pirandelliano vi fu una breve recensione di croce, pubblicata nel 1909 su “La Critica”. Croce sembra essere in parte infastidito dallo spettacolo di un letterato che da filosofo affronta un tema – l’umorismo – senza nemmeno soffermarsi su ciò che egli aveva a suo tempo scritto su questo argomento.
E tuttavia, al di là di queste motivazioni di basso profilo, all’origine della polemica vi ò una differenza di natura teorica: per Croce, infatti, un’essenza dell’umorismo non vi è, poiché vi è soltanto l’atteggiamento storicamente mutevole che i singoli umoristi assumono nelle loro opere. Vi sono umoristi, ma non l’umorismo: cercare di fissarne l’essenza significa allora, per Croce, perdersi nelle analisi psicologiche tanto care alla cultura positivistica, ma così lontane dalle prospettive dell’idealismo storicistico verso cui Croce sente di doversi orientare. Al contrario, le pagine pirandelliane sono caratterizzate dalla convinzione che un’essenza dell’umorismo vi sia e che debba essere indagata proprio nei termini psicologici suggeriti dalla cultura positivistica ed in particolare da Theodor Lipps – un autore che Pirandello critica, ma da cui almeno in parte dipende. Così Pirandello si discosta sin da principio da ogni tentativo di rendere conto della natura dell’umorismo nei termini di un’indagine storico-letteraria: a suo avviso, l’umorismo non ò affatto una forma dello spirito sorta nella letteratura moderna dell’Europa settentrionale, come pure si era più volte sostenuto.
L’umorismo non ò una categoria storica, ma è un concetto che circoscrive un comportamento umano relativamente stabile nel tempo e comunque indagabile con gli strumenti dell’indagine psicologica. Su questo punto, dunque, Pirandello ò vicino allo psicologismo di fine Ottocento, anche se, come vedremo, la riflessione sull’umorismo si staglia su di uno sfondo di natura esistenziale: l’analisi dei meccanismi psicologici dell’umorismo diviene così una riflessione tipicamente novecentesca su di una struttura di fondo dell’esistenza, su un modo di atteggiarsi dell’uomo rispetto alla propria vita ed al mondo.
3. Ironia e umorismo: l’Orlando furioso e il Don Quijote. Per venire a capo della natura dell’umorismo, Pirandello segue la via di una caratterizzazione per contrasto: si chiede cioè che cosa differenzi l’atteggiamento umoristico da quello ironico. Ora, il materiale che permette di tracciare questa distinzione può essere ricavato dalla storia della letteratura, e più precisamente dalla contrapposizione di due grandi opere che affrontano in una differente prospettiva il mondo antico degli ideali cavallereschi: l’Orlando furioso e il Don Quijote.
L’Orlando furioso ò, per Pirandello, il poema ironico per eccellenza. Il sorriso dell’ironia ha una sua funzione negativa: richiama il soggetto dall’oggetto, negandolo, e mostra come l’io non si perda nel mondo che descrive. Questa dunque ò la funzione del riso cui Ariosto ci invita: Ariosto, scrive Pirandello, descrive infatti un mondo epico cui non crede più, e lo descrive lasciandoci ogni tanto percepire la sua estraneità ai valori del mondo cavalleresco. Così, anche senza addentrarsi nella trama dei significati che spettano al concetto ariostesco di finzione, risulta con chiarezza come l’ironia si giochi proprio sul crinale che separa l’illusione della favola dalla sua illusorietà , l’adesione ingenua del lettore alla narrazione dalla sua complicità con l’autore che ne svela la natura fantastica.
Pirandello chiarisce bene il suo pensiero con una breve citazione dal poema ariostesco. Ruggiero ò sull’ippogrifo – questa iperbole della velocità e della leggerezza – e vola alto nelle regioni aeree del cielo. Ma, avverte Ariosto, resta tuttavia un uomo, fatto di greve miscela terrestre: “Non crediate, signor, che però stia / per sì lungo cammin sempre sull’ale: / Ogni sera all’albergo se ne gia / schivando a suo poter d’alloggiar male”. Nella favola, commenta Pirandello, diviene evidente la realtà ; il sogno si spezza, poiché il sognatore ci avvisa di essere ben desto: il sorriso ironico dell’autore ci strappa alla finzione aerea dell’ippogrifo e ci ricorda la stanchezza dei viaggi e le piccole quotidiane preoccupazioni del viaggiatore.
Alla funzione negatrice dell’ironia si contrappone la natura intimamente contraddittoria dell’umorismo: dall’Orlando furioso dobbiamo muovere al Don Quijote. Anche le pagine di Cervantes ci fanno spesso ridere, e il riso in questo caso non sorge per ridestarci da qualche finzione, ma per mostrarci nella realtà quanto alla realtà siano inadeguati i sogni e gli ideali del “cavaliere dalla triste figura”. Don Quijote scambia per giganti i mulini a vento, e noi lettori ridiamo per la cecità di quest’uomo imbevuto di favole, per la sua incapacità dio accettare la prosaicità del reale, il suo necessario scarto rispetto ai sogni della nostra immaginazione.
E tuttavia il gesto comico del cavaliere che si fa disarcionare da un innocuo mulino a vento non ò solo fonte di riso: ci costringe anche a pensare al nostro rapporto con il mondo, al nostro avere da tanto tempo rinunciato a cercare nel mondo reale il mondo fantasticato. Il mondo degli ideali ò diventato il mondo dei sogni, ed il lettore di Cervantes, non appena si rende conto che ridicola ò proprio la grandezza e la nobiltà di Don Quijote, può ridere solo di un riso amaro. Il sorriso umoristico può nascere solo sulle ceneri del riso comico e sorge non appena comprendiamo che nel gesto ridicolo di Don Quijote si fa avanti una critica disperata della realtà , una critica che ha nel suo fallimento qualcosa di altamente tragico.
Di qui possiamo muovere per trarre le prime conclusioni: il riso umoristico non ha la pienezza ingenua della comicità, ma è venato da un sentimento contrastante che lo limita e lo contiene. Così, quando passiamo dalla comicità all’umorismo, il riso si fa amaro: certo, ridiamo ma insieme commiseriamo la sorte di chi pure troviamo ridicolo. Alla base dello stato d’animo che l’umorismo ci procura vi ò dunque una vera e propria contraddizione emotiva: scherno e compassione si legano insieme e il riso si smorza e si vela di tristezza.
A questa contraddizione sul terreno emotivo fa da eco e da fondamento la contraddittorietà dei rapporti del soggetto umoristico con il mondo. Per tornare ancora una volta al nostro esempio: come lettori di Cervantes, ridiamo della lotta contro ai mulini a vento perchè noi, gente compita, mai ci impegneremmo in un simile sciocco confronto. Eppure, non appena prendiamo le distanze dal mondo di Don Quijote e ci sentiamo così lontani dalle sue stranezze da poterne ridere tranquillamente, ecco che il suo mondo si fa nuovamente presso di noi: non siamo come Don Quijote, ma siamo pure uomini come lui, siamo forse più cinici e disillusi, ma egualmente ogni tanto ci abbandoniamo alla dolcezza ingenua dell’incanto. All’ironia e alla sua funzione negatrice si contrappone così l’umorismo in cui si esprime un atteggiamento apertamente contraddittorio.
4. Il sentimento del contrario. Nella definizione del concetto di umorismo o meglio nella descrizione di “quell’intimo processo che avviene, e che non può non avvenire, in tutti quegli scrittori che si dicono umoristi” (ivi, pp. 133-4) Pirandello dipende senz’altro da Lipps, e per Lipps l’umorismo affonda le sue radici nella comicità poichè ò appunto un superamento del comico attraverso il comico. Ora, per Pirandello come per altri autori, la comicità sorge dalla constatazione dell’inadeguatezza di un comportamento, di un modo di dire, di un gesto o anche soltanto di un viso: ci basta infatti imbatterci in una donna anziana truccata vistosamente, quasi a suggerire l’immagine di una giovinezza ormai inesorabilmente passata, perché – nota Pirandello – il riso si faccia avanti. – di qui la definizione proposta da Pirandello: la comicità nasce dall’avvertimento del contrario.
La realtà non ò come ci si vorrebbe far credere, e ridendo esprimiamo il nostro verdetto di condanna sulle apparenze e ribadiamo la loro difformità dal vero. Dalla comicità passiamo tuttavia all’umorismo quando il contrasto non ò più soltanto avvertito, ma ò per così dire colto in tutta la pienezza del suo significato: l’umorismo ò appunto il sentimento del contrario. Non si tratta di definizioni ben scelte, anche perchè esse illuminano soltanto l’esito finale di quell’intimo processo che Pirandello ha cuore.
Tuttavia, se non ci fermiamo alle parole, ma cerchiamo di far luce sul loro significato, il senso della proposta pirandelliana si fa più chiaro e convincente. L’umorismo poggia sul terreno mobile della comicità : ha origine dunque dall’avvertimento del contrario e dalla condanna che, ridendo, pronunciamo. Ma l’umorismo ò superamento della comicità : implica dunque la presenza di un operatore nuovo – la riflessione – che ci permetta di lasciare alle nostre spalle la comicità . Due sono le funzioni che la riflessione esercita. La prima consiste nel mettere a distanza noi stessi: la riflessione ci permette di infatti di analizzare freddamente i nostri stati d’animo, ci consente di giudicarli, vagliando e soppesando i motivi che li hanno determinati (ivi, p 135).
Di qui il secondo compito cui la riflessione assolve: riflettendo sui nostri stati d’animo, impariamo anche a relativizzarli, a cogliere le ragioni di ciò che avevamo precedentemente negato. Torniamo allora alla situazione comica da cui avevamo precedentemente preso le mosse: dalla vecchia che si maschera da giovane e che, proprio per questo, desta lo spirito critico della comicità. Questa volta tuttavia il riso non riempie per intera la coscienza, ma cede la scena alla riflessione che ci mostra ciò che di ingenuo ò racchiuso nel gesto di negazione della soggettività : certo, ò ridicolo chi non sa accettare il trascorrere del tempo, ma ò ben vero che basta riflettere un poco per scoprire che tutti cerchiamo di esorcizzare la vecchiaia e la morte.
Ridiamo, ma la riflessione ci costringe a scoprire le ragioni di ciò che ò deriso, apre una breccia nello stato d’animo che ci separa dall’altro e riscopre una comunanza che la comicità aveva negato. Continuiamo ad avvertire il contrario che ci fa ridere, ma ora ne avvertiamo le ragioni e impariamo a scorgere nell’inadeguatezza comica una contraddizione insita nella stessa natura umana: la riflessione – commenta Pirandello – lavorando in me, mi ha fatto andar oltre quel primo avvertimento, o piuttosto più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed ò tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico (ivi, p. 135).
5. La riflessione e la letteratura umoristica. Sottolineare il ruolo della riflessione nell’umorismo ò importante anche perché Pirandello muove di qui per indicare alcuni tratti caratteristici dello stile delle opere umoristiche. L’umorismo chiede che il soggetto non sia dominato dalle passioni: l’ umorista dovrà saper raccontare senza “lasciarsi prendere la mano” dalla storia che viene narrando.
Di qui alcuni tratti caratteristici della letteratura umoristica. In primo luogo la sua tendenza alle digressioni: l’umorismo spezza di frequente l’unità della trama per inserire un nuovo e differente punto di vista che permetta di relativizzare l’intreccio delle passioni e dei sentimenti. Questo stesso obiettivo può tuttavia essere raggiunto, in secondo luogo, grazie all’intervento diretto dell’ autore che, commentando in qualche modo gli eventi, ci costringe ad abbandonare la nostra posizione di lettori, immersi nella vicenda, per divenire ad un tratto solidali con una posizione ad essa esterna, con una prospettiva che, proprio per essere sita al di là della trama, può facilmente divenire umoristica. Nel raccogliere queste poche osservazioni, Pirandello sembra pensare ad autori come Manzoni o Sterne: nei tratti che abbiamo appena indicato non sarebbe tuttavia illegittimo scorgere anche alcune delle caratteristiche più tipiche dello stile pirandelliano.
6. L’umorismo e la filosofia di Pirandello. Prima di concludere le nostre considerazioni vorremmo chiederci quali sono le ragioni che spingono Pirandello a riflettere con tanto impegno su questo tema. Ora, la risposta a questo interrogativo traspare nelle ultime pagine del suo saggio e può essere formulata così: l’umorismo è un tratto essenziale della condizione umana e fa tutt’uno con la filosofia della vita che anche in questo saggio Pirandello fa sua. La prima significativa opera in cui Pirandello delinea una filosofia dell’esistenza e della condizione umana è senz’altro Il fu Mattia Pascal, ed ò proprio alla buon’anima di quel bibliotecario che ò dedicato il saggio sull’umorismo.
Si tratta di una scelta su cui è opportuno riflettere e che ci costringe innanzitutto a far luce sull’ elemento umoristico del romanzo, un elemento che traspare con chiarezza nell’apologo finale che ci presenta Mattia Pascal nell’atto di deporre fiori sulla sua tomba. Vi è un senso in cui questa scena è senz’altro comica: quale gesto può sembrarci più ridicolo e sciocco che portare fiori sulla tomba di un vivo? E tuttavia l’avvertimento del contrario può facilmente trapassare nel suo sentimento: non solo Mattia Pascal, ma ogni uomo seppellisce se stesso poiché rimane impaniato nelle forme morte dell’esistenza, in quelle convenzioni ed abitudini che si sedimentano col tempo, rendendo invisibile il fluire continuo della vita che al di là da esse scorre inesorabilmente.
In questa filosofia della vita, in cui è chiara l’eco di Bergson o di Simmel, non è difficile scorgere la genesi di molti temi pirandelliani, ed anche la sua dottrina dell’umorismo affonda qui le sue radici. Sostenere che la vita si ò persa ed arenata nelle sue morte forme vuol dire infatti alludere ad una situazione, in ultima istanza, comica: l’uomo ò diventato prigioniero delle convenzioni e le sue azioni rammentano quelle di un burattino – e il burattino ò un luogo classico della comicità. Dalla comicità all’umorismo il passo ò breve: basta rendersi conto che l’irrigidimento della vita che ci spinge a ridere di un qualche personaggio ò in realtà un tratto caratteristico della natura umana. Il riso ingenuo e aperto che sorge non appena cogliamo nei gesti di un uomo la meccanica rigidità del burattino, si vena di tristezza e di amarezza non appena impariamo a ritrovare nel burattino l’uomo. L’atteggiamento umoristico si pone così, in Pirandello, come il frutto cui conduce un’amara filosofia dell’esistenza.