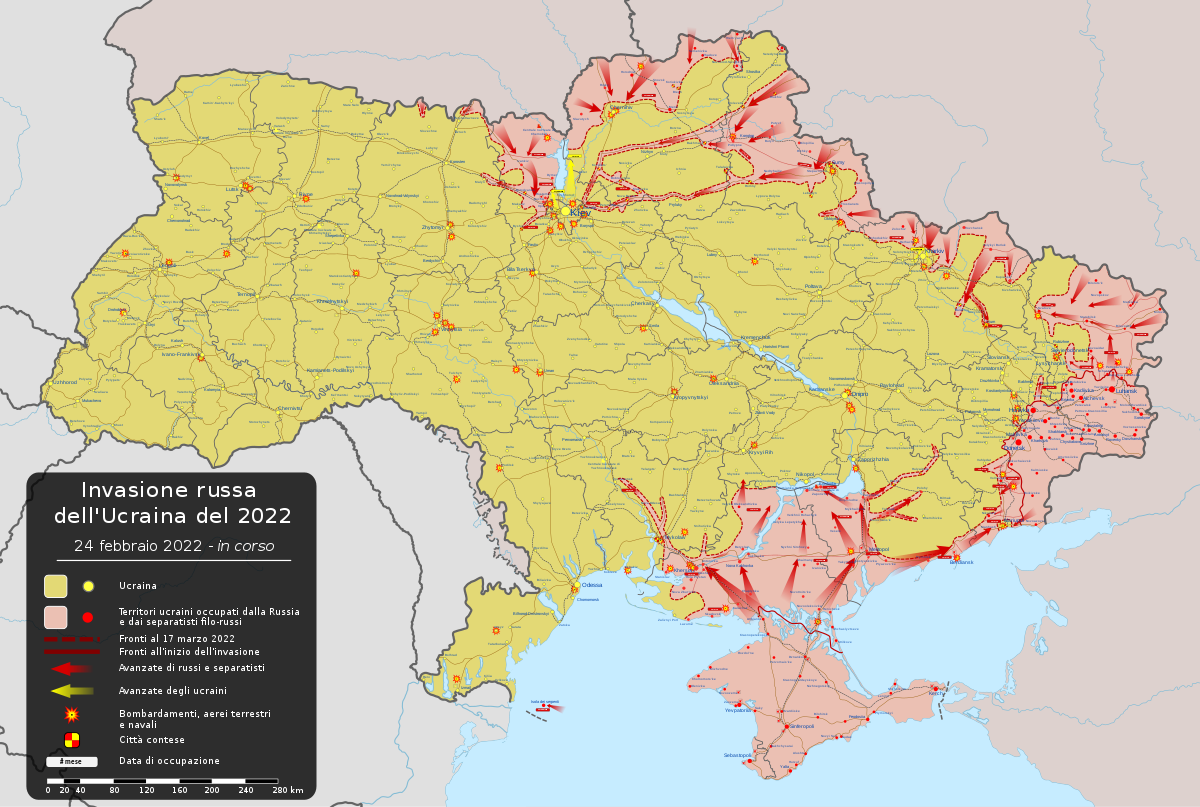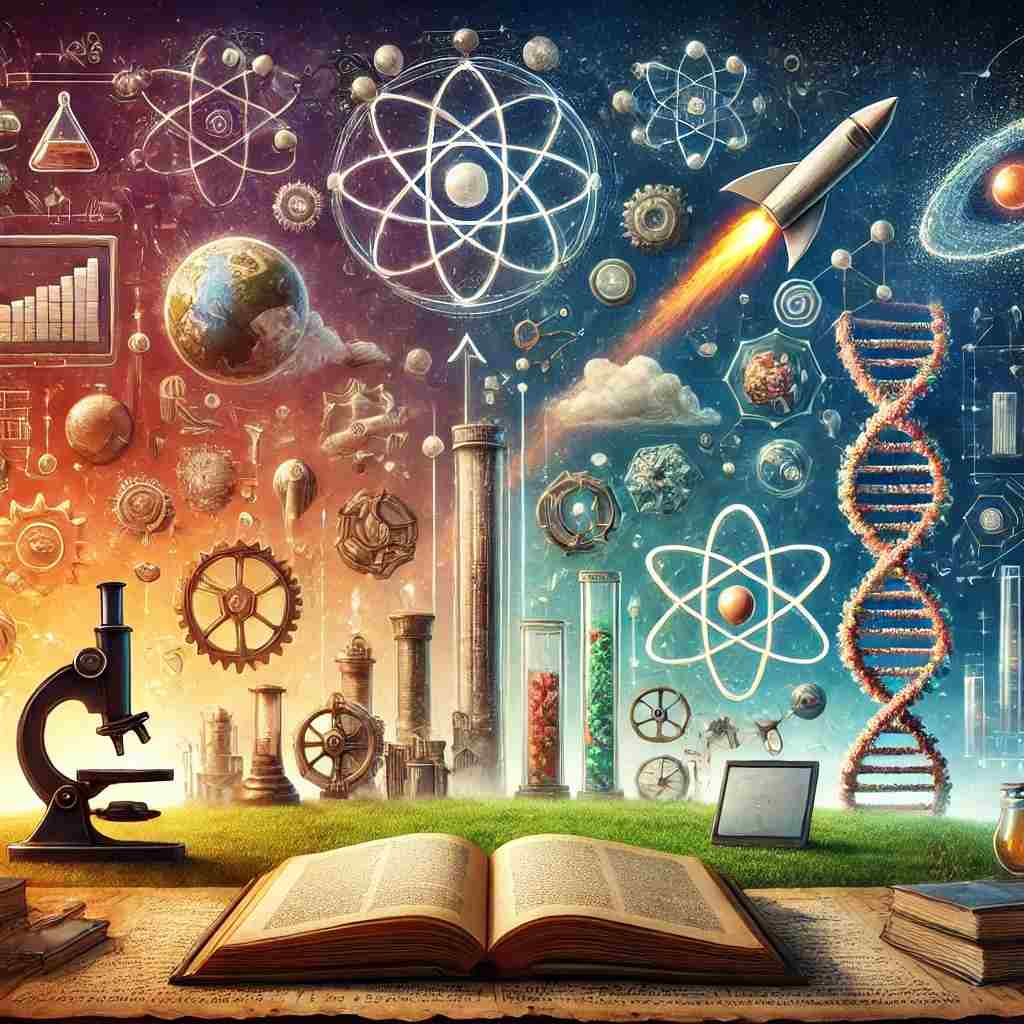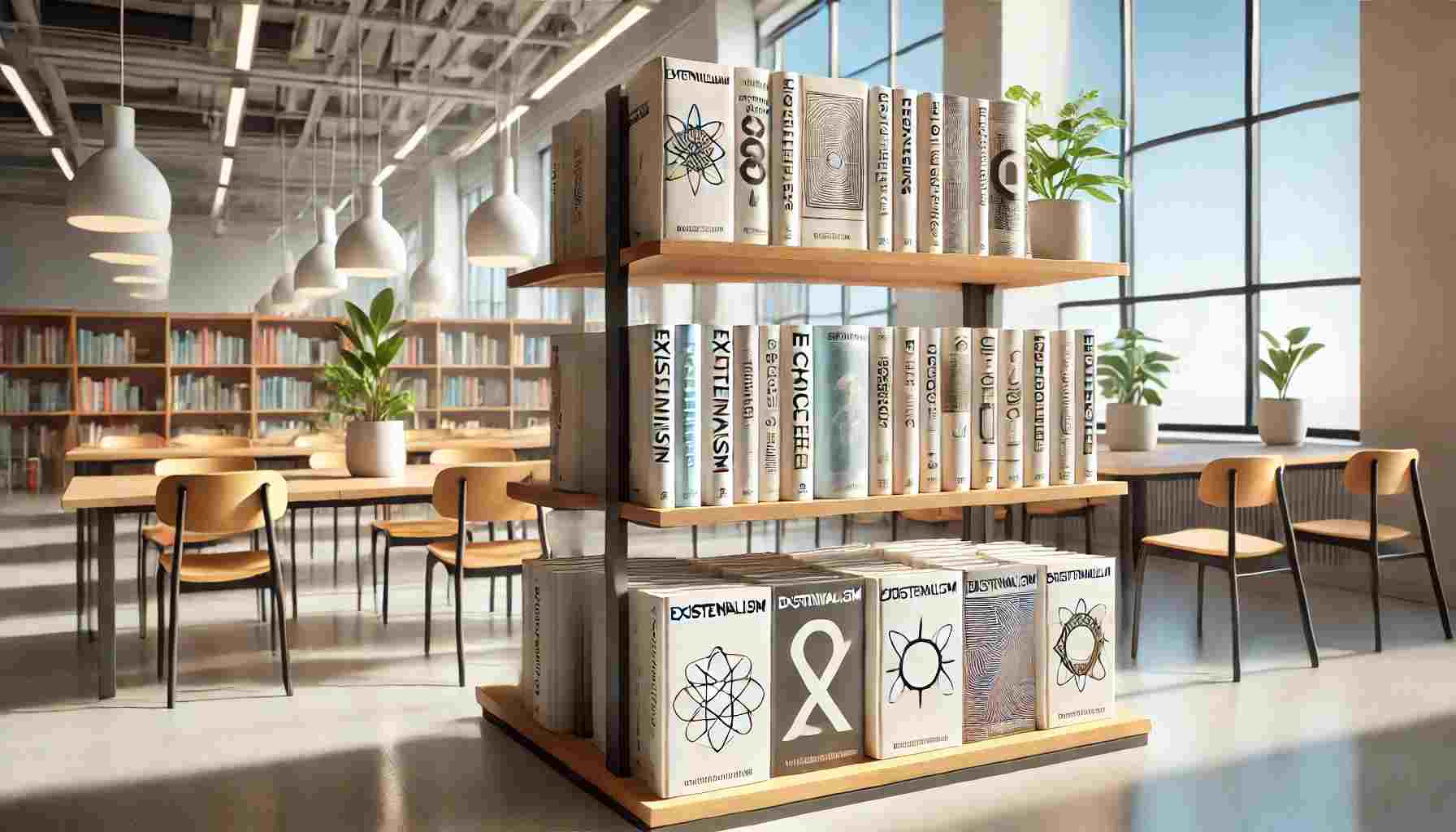I testi suggeriti dalla traccia evidenziano la differente sensibilità dei due autori citati rispetto al concetto di “prigionia”. Con ogni evidenza, una visione particolarmente cupa è quella di Montale in “Il sogno del prigioniero”. La dichiarazione di claustrofobica impotenza, manifesta sin dal primo verso (“Albe e notti qui variano per pochi segni”) prosegue con l’elencazione degli stessi segni, presunti o reali che siano. Le uniche vie d’uscita concrete sono l’abiura, la confessione, il tradimento; atti in sé spregevoli ma che guadagnano il passaggio da cibo a cuoco. E allora la via di fuga laterale dell’immaginazione spunta come unica speranza di evasione. Eppure, nella cupezza dei versi di Montale brilla in un certo senso una luce, seminata in due punti diversi del testo: “Ma la paglia é oro, la lanterna vinosa é focolare se dormendo mi credo ai tuoi piedi. […] L'attesa é lunga, il mio sogno di te non e finito”.
Differente e, imprevedibilmente meno soffocante, è la visione rimandata dai versi dell’Infinito di Leopardi e che viene individuata da un “ma”, che separa l’esclusione della limitatezza dello sguardo fisico dall’onnipotenza dello spazio, e ancora di più del “pensier” che si inerpica ben al di sopra dell’ermo colle. Un di sopra in cui lo stesso pensiero “annega”, è vero, ma con una modalità assolutamente soddisfacente, inebriante, quasi “dolce”. Ecco se esiste un punto di contatto fra i due testi esso risiede in questo superamento della realtà fisica opprimente (il carcere/il colle) per mezzo di un punto di fuga che è collocato al di là dello spazio, del tempo: “il sogno di te” in un caso, e “l’immensità” nell’altro.
Poesia limpida, certo, che restituisce in maniera impeccabile la percezione dolorosa e drammatica della limitatezza e della finitezza della fisicità, dell’impotenza legata alla costrizione, di qualsiasi tipo essa sia. L’uomo, sembrano dirci le due poesie, può essere imprigionato fra mura reali o limiti fisici (malattie, malformazioni) o imprigionarsi da se medesimo in recinti psichici (solitudine, inadeguatezza, paranoia) e soffrire senza speranza di venirne fuori, per la propria incapacità di metter fine a tali sofferenze. Comune a tutte queste esperienze, però, è il desiderio di porre fine allo stato di fatto. Il poeta le oltrepassa grazie alla poesia (e talvolta neanche con quella), l’uomo normale, in ultima istanza, persino con la morte.
Se, però, l’opzione di una morte provocata da sè, non è citata nei testi poetici citati, è innegabile come si insinui nell’animo di ogni uomo, ogni qual volta che la forza dell’immaginazione o dell’amore o della poesia, risultino incapaci a realizzare il superamento degli ostacoli. La Chiesa non considera praticabile questa opzione. In alcun caso. Secondo il dogma, la vita è per eccellenza il “dono di Dio”, un mistero da contemplare. Una realtà sacra che in realtà le scritture non prevedono mai come comprensibile nella sua interezza e, soprattutto, non disponibile a qualsiasi tipo di scelta che l’uomo intende fare, in quanto comunque frutto di un dono, e in un certo senso proprietà di Dio. Il punto è questo, in realtà: se la vita è un dono, perché il destinatario non può disporne?
Addentrarsi ulteriormente su questo territorio, porterebbe a scivolare nei meandri e nelle discussioni riguardanti il significato della vita in genere, e il significato, e il destino di quella umana in particolare. La vita come trascendenza o come semplice transito? La vita come processo contemplativo o itinerario verso un al di là sconosciuto e comunque non conoscibile dall’uomo durante la propria vita? Su queste argomentazioni, ovviamente, ci sarebbe da discutere a lungo – e di fatto, lo si fa da millenni – e probabilmente non potrebbe risultare utile, per una volta, neanche appellarsi alle più recenti scoperte scientifiche. La morte cerebrale, per esempio, come l’inizio della stessa vita, sono degli istanti anche scientificamente di ardua e controversa determinazione, e pertanto è particolarmente difficile delimitare, all’inizio come alla fine, il recinto della vita.
Quello che potrebbe invece risultare discriminante, nell’ambito di una scelta di una donna o un uomo che chiedono, desiderano, inducono se stessi o un’altra persona a mettere fine alla propria vita, non considerando meritevoli di essere considerate tali le condizioni in cui questa si sviluppa, è il concetto classico di “piètas”. La compassione, potrebbe essere la lente attraverso cui valutare il limite ultimo della sofferenza che una persona vuole o può sopportare, una sofferenza che in alcuni casi può andare persino oltre quella dignità della vita, che la Chiesa medesima giudica irrinunciabile. La devastazione delle più elementari funzioni vitali, il dipendere in tutto e per tutto – indefinitamente – da macchine, artefatti umani che se non esistessero non consentirebbero l’esistenza un solo istante di più, sembra tutt’altro, infatti, che una dignitosa condizione vitale. La desistenza dall’accanimento terapeutico, invece, potrebbe essere una liberazione, o quantomeno il legittimo diritto a intraprendere quell’ultimo, irrinunciabile tragitto della vita.
Questo è, almeno a ripercorrerne l’etimologia del termine, il significato dell’ Eu-tanasia: buona morte. Un concetto intorno al quale, in realtà si dibatte fin dalla Grecia antica e che irrompe nel mondo occidentale nei primi anni del 1600, per opera di F. Bacon, nella accezione più letterale possibile di “attività connessa a limitare le sofferenze connesse al termine della vita”.
La questione diventa in realtà ancora più controversa e spinosa, nel momento in cui si pone all’attenzione dell’uomo, l’opportunità di “agevolare” il rito del passaggio, per le cause più disparate, finendo col definire a livello medico e giuridico, persino una “eutanasia attiva” (decesso indotto) e una “passiva” (interruzione di farmaci o trattamenti tesi a prolungare l’esistenza della persona). Nel primo caso, si parla di eutanasia diretta o indiretta (tramite o meno la somministrazione di farmaci atti a provocare direttamente la morte o farmaci che hanno come effetto secondario il medesimo risultato); o ancora, di volontaria (attuata dietro richiesta specifica del soggetto) o non-volontaria (intrapresa direttamente da un terzo). Nell’ambito di quest’ultimo, si comprende, naturalmente, anche la pratica del cosiddetto “suicidio assistito”, un’ operazione durante la quale un sanitario, senza intervento diretto, assiste professionalmente un soggetto che assume tale decisione.
L'eutanasia, il sogno del prigioniero
Talvolta nello scafandro non ci sono farfalle, e un danno cerebrale diventa irreversibile. Mentre i poeti sinterrogano sulla propria prigione mentale (Montale: Il sogno del prigioniero; Leopardi: Linfinito), i preti si affannano a predicare il valore della vita. Anche di quella vissuta come vegetali imprigionati (nel corpo) in un letto dospedale? A partire dallo spunto letterario, esponi le tue conoscenze in merito allargomento di evidente attualità, e rifletti argomentando sul significato di eutanasia.