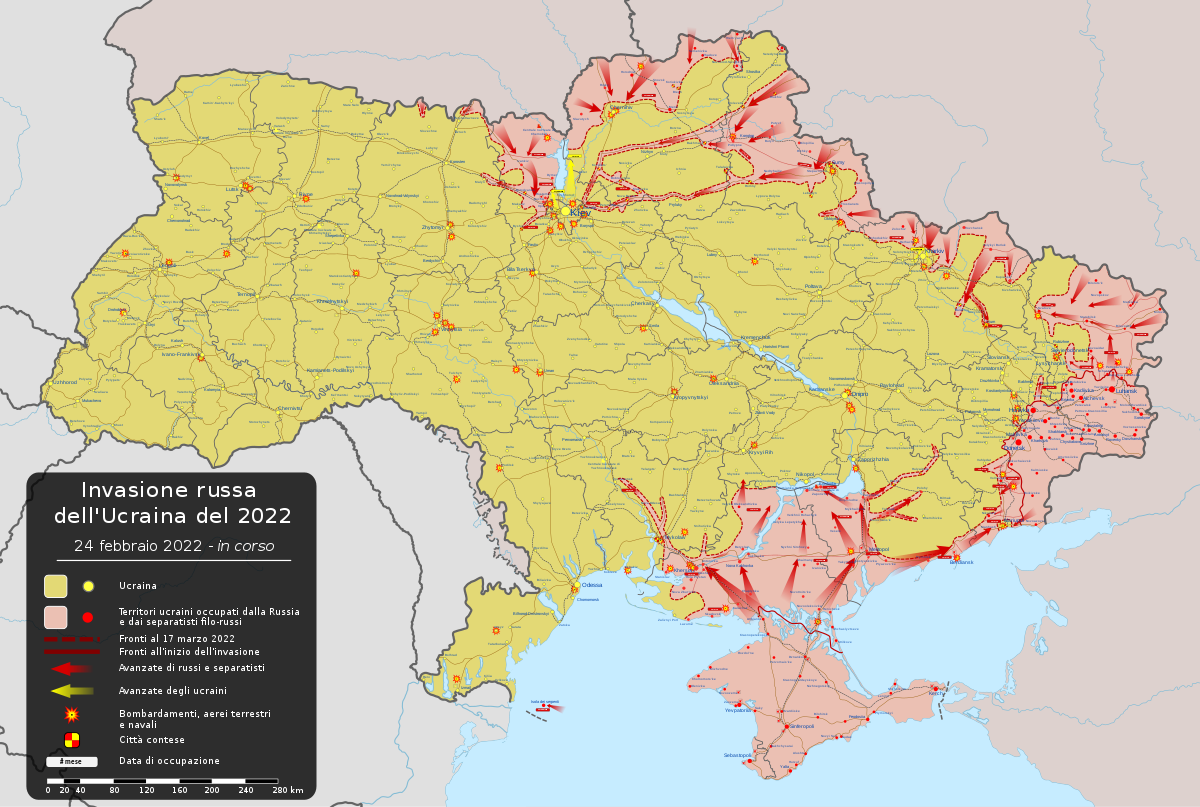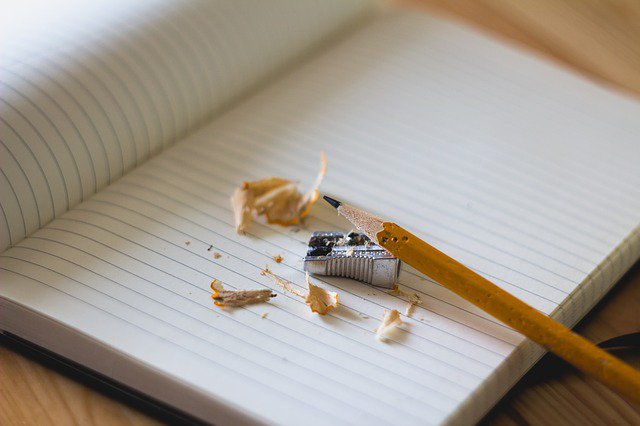Il femminicidio e la violenza sulle donne rappresentano tematiche di drammatica attualità che potrebbero costituire l’argomento centrale di una traccia per la Prima Prova dell’Esame di Stato. Questi fenomeni, radicati in dinamiche di potere e disuguaglianza di genere, continuano a manifestarsi con allarmante frequenza nella società contemporanea, suscitando dibattiti e riflessioni che coinvolgono l’intero tessuto sociale.
I dati sono inquietanti: ogni tre giorni in Italia una donna viene uccisa, prevalentemente in ambito familiare o affettivo. Nel 2023, su circa 300 omicidi complessivi, oltre un terzo riguardava donne. Più allarmante ancora, l’80% dei femminicidi avviene per mano di partner, ex partner o familiari, evidenziando come la violenza si consumi principalmente all’interno di relazioni di fiducia. La statistica rivela inoltre che quasi il 32% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita, ma solo il 12% delle vittime denuncia.
Questa tematica si presta particolarmente a una traccia di tipologia C (tema di attualità) o B (testo argomentativo), richiedendo ai candidati di dimostrare conoscenza del fenomeno, capacità di analisi critica e di argomentazione. Un tema sul femminicidio permette di esplorare molteplici dimensioni: sociologica, giuridica, psicologica e culturale.
Nell’affrontare questo argomento all’Esame di Stato, sarà fondamentale sviluppare una riflessione che contempli le definizioni di femminicidio e violenza di genere, l’analisi statistica del fenomeno, le radici culturali e sociali della violenza contro le donne, il quadro legislativo italiano ed europeo e le possibili strategie di prevenzione e sensibilizzazione. Il tutto mantenendo un approccio critico che eviti sia la banalizzazione sia il sensazionalismo, dimostrando sensibilità e rigore analitico su un tema che rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani nel nostro paese.
Definizione e contestualizzazione storica
Il termine “femminicidio” identifica l’omicidio di una donna in quanto donna, distinguendosi da altre forme di violenza per la sua natura sistemica radicata in dinamiche di potere patriarcali. Non si tratta semplicemente di un crimine contro un individuo, ma di un fenomeno che riflette disuguaglianze strutturali tra generi.
Secondo il vocabolario Devoto-Oli della lingua italiana, il femminicidio rappresenta “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte”.
La concettualizzazione moderna del termine si deve principalmente all’antropologa messicana Marcela Lagarde, che negli anni ’90 ha trasformato il termine inglese “femicide” (coniato dalla femminista Diana Russell negli anni ’70) in “feminicidio”. La rielaborazione di Lagarde amplia il concetto includendo la dimensione di impunità e la responsabilità istituzionale, sottolineando come lo Stato possa diventare complice indiretto attraverso l’inerzia o l’inadeguatezza delle risposte.
La violenza di genere si manifesta in varie forme, che vanno oltre l’aggressione fisica:
- Violenza fisica (percosse, lesioni, omicidio)
- Violenza sessuale (molestie, stupro, abusi)
- Violenza psicologica (manipolazione, minacce, umiliazioni)
- Violenza economica (controllo finanziario, impedimento all’indipendenza economica)
- Stalking (persecuzione, controllo ossessivo)
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la violenza contro le donne come “qualsiasi atto di violenza di genere che comporti, o abbia probabilità di comportare, sofferenze o danni fisici, sessuali o mentali per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.
La consapevolezza sociale di questa problematica ha seguito un’evoluzione graduale. In Italia, un momento cruciale è stato l’abrogazione del cosiddetto “delitto d’onore” nel 1981, che prevedeva una significativa riduzione della pena per chi uccideva la moglie, figlia o sorella per difendere “l’onore della famiglia”. Fino a quel momento, l’ordinamento italiano considerava la gelosia e l’onore attenuanti per crimini efferati contro le donne.
Un passaggio fondamentale nel riconoscimento internazionale della violenza di genere come problema strutturale è stata la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993. Questo documento ha sancito ufficialmente che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali.
Negli anni successivi, la Convenzione di Istanbul (2011) ha rappresentato un altro momento decisivo, stabilendo standard vincolanti per prevenire e contrastare la violenza contro le donne a livello europeo. L’Italia ha ratificato questa convenzione nel 2013, impegnandosi a implementare politiche integrate per la protezione delle vittime e la persecuzione dei responsabili.
L’evoluzione della terminologia riflette anche un cambiamento culturale: dall’uso di espressioni come “delitto passionale” o “tragedia familiare”, che tendevano a minimizzare e privatizzare il fenomeno, si è passati a termini come “femminicidio” che evidenziano la dimensione socio-politica della violenza. Questo spostamento semantico è stato accompagnato e sostenuto dai movimenti femministi, che hanno contribuito a portare il problema dalla sfera privata al dibattito pubblico e politico.
Dati e casi emblematici sul femminicidio in Italia
Il femminicidio in Italia si manifesta attraverso numeri allarmanti che testimoniano la gravità di un fenomeno radicato nella società. Secondo i dati ISTAT e i report del Ministero dell’Interno, ogni anno vengono uccise circa 100-120 donne, con una media di una donna ogni tre giorni. Nel 2023, su circa 300 omicidi complessivi, oltre un terzo riguardava donne, uccise prevalentemente in ambito familiare o affettivo.
Un aspetto particolarmente preoccupante è rappresentato dal contesto in cui avvengono questi crimini: oltre l’80% dei femminicidi si consuma per mano di partner, ex partner o familiari. Questo dato evidenzia una caratteristica distintiva della violenza di genere rispetto ad altre forme di violenza: mentre gli uomini sono più frequentemente vittime in contesti pubblici e da parte di sconosciuti, le donne vengono prevalentemente aggredite nell’ambito delle relazioni intime, da persone che dovrebbero rappresentare sicurezza e protezione.
I dati del 2024 confermano la persistenza del fenomeno, con 98 donne uccise secondo i dati del Viminale e 87 femminicidi confermati dall’associazione “Non una di meno”. Particolarmente significativo è il dato relativo alle denunce pre-esistenti: solo il 10% delle vittime aveva precedentemente segnalato violenze alle autorità, secondo le ricerche del CNR.
Il caso Cecchettin
Tra i casi emblematici che hanno segnato profondamente la coscienza collettiva, quello di Giulia Cecchettin (novembre 2023) rappresenta un esempio paradigmatico delle dinamiche che caratterizzano il femminicidio. La giovane studentessa di ingegneria, 22 anni, è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta dopo aver interrotto la relazione. La vicenda ha assunto un rilievo mediatico particolare anche perché Giulia, prossima alla laurea, aveva deciso di terminare una relazione che le causava sofferenza, mentre il suo ex non accettava questa decisione.
Il caso ha scatenato importanti manifestazioni in tutta Italia, portando a una rinnovata discussione pubblica sul tema del possesso e del controllo nelle relazioni affettive.
Altri casi significativi
Negli ultimi anni, numerosi altri femminicidi hanno colpito l’opinione pubblica, come quello di Alessandra Matteuzzi (2022), uccisa dall’ex compagno dopo averlo denunciato per stalking; di Vanessa Scialfa (2023), assassinata dal marito davanti ai figli piccoli; e di Roua, 31 anni (Torino), accoltellata dall’ex marito nonostante precedenti denunce.
Un aspetto particolarmente doloroso è il coinvolgimento di minori: nel 2024 si registra una vittima di appena 13 anni, e in 10 casi i figli sono stati testimoni dell’omicidio della madre.
Tabella riassuntiva: Il femminicidio in Italia
| Indicatore | Dato | Fonte/Note |
|---|---|---|
| Frequenza | Una donna uccisa ogni 3 giorni | Ministero dell’Interno |
| Contesto | 80% in ambito familiare/affettivo | ISTAT |
| Tasso di violenza | 32% delle donne (16-70 anni) | ISTAT |
| Tasso di denuncia | Solo 12% delle vittime denuncia | ISTAT |
| Femminicidi nel 2024 | 87-98 (a seconda delle fonti) | Viminale/Non una di meno |
| Denunce pre-esistenti | 10% delle vittime aveva denunciato | CNR |
| Tentati femminicidi 2024 | 44 | Osservatorio transfemminista |
| Orfani di femminicidio 2024 | 43 | Osservatorio Diritti |
Questi dati e casi non sono semplici numeri, ma rappresentano storie di vite spezzate che testimoniano l’urgenza di un intervento sistemico su molteplici livelli: educativo, sociale, giuridico e culturale.
Analisi socioculturale della violenza di genere
La violenza contro le donne non è un fenomeno isolato, ma rappresenta l’espressione di dinamiche socioculturali profondamente radicate nella società. Per comprendere il femminicidio è necessario analizzare il tessuto sociale e culturale in cui esso si manifesta.
Le radici culturali del femminicidio
La cultura patriarcale costituisce il terreno fertile in cui la violenza di genere prolifera. Tale sistema si fonda su presupposti di disuguaglianza che legittimano, esplicitamente o implicitamente, la supremazia maschile e la subordinazione femminile. Secondo recenti studi sociologici, persistono ancora oggi idee come:
- La concezione della donna come proprietà dell’uomo
- L’accettabilità del controllo maschile nelle relazioni affettive
- La normalizzazione della gelosia come dimostrazione d’amore
- La suddivisione rigida dei ruoli di genere all’interno della famiglia
Questi stereotipi, tramandati attraverso generazioni, influenzano profondamente le relazioni interpersonali e contribuiscono a creare un ambiente in cui la violenza viene minimizzata o giustificata.
L’Italia presenta peculiarità culturali che rendono ancora più complessa la questione. Come evidenziato da diversi studi, il nostro paese mantiene una visione tradizionalista della famiglia che spesso ostacola l’autonomia femminile. Il 31% degli italiani ritiene ancora che le donne dovrebbero prioritizzare la famiglia rispetto alla carriera, percentuale significativamente superiore alla media europea.
Fattori determinanti e interconnessioni
Il femminicidio è il risultato di una complessa interazione tra fattori individuali, relazionali, comunitari e sociali che operano a diversi livelli:
| Livello | Fattori | Impatto |
|---|---|---|
| Individuale | Disturbi psicologici, abuso di sostanze, vittimizzazione pregressa | 22% dei casi di violenza presenta comorbidità |
| Relazionale | Dinamiche di controllo, dipendenza emotiva, difficoltà comunicative | 69% dei femminicidi coinvolge partner o ex |
| Comunitario | Disoccupazione, isolamento sociale, mancanza di reti di supporto | Aumento del 24% durante periodi di crisi economica |
| Sociale | Accettazione della violenza, disparità economica, insufficienza istituzionale | 50% delle vittime non denuncia per sfiducia |
È fondamentale sottolineare che, sebbene esistano fattori di rischio, la responsabilità rimane sempre dell’aggressore, che compie scelte consapevoli. Nessuna giustificazione basata su “raptus” o “gelosia” può attenuare la gravità di questi atti criminali.
Media e rappresentazione della violenza
I mezzi di comunicazione svolgono un ruolo determinante nella percezione pubblica del femminicidio. L’analisi della narrazione mediatica rivela criticità significative:
- Sensazionalismo: La tendenza a focalizzarsi sui dettagli cruenti distoglie l’attenzione dalle cause strutturali.
- Vittimizzazione secondaria: Scrutinio eccessivo della vita privata e delle scelte della vittima.
- Giustificazione implicita: Uso di espressioni come “era ossessionato”, “folle gelosia” che patologizzano comportamenti controllanti.
- Linguaggio inappropriato: Definire “delitto passionale” un femminicidio ne minimizza la gravità.
Secondo l’Osservatorio di Pavia, l’80% delle notizie su femminicidi contiene almeno un elemento di rappresentazione problematica, mentre solo il 5,3% dei post politici affronta il tema in modo approfondito, evidenziando un “underreporting” sistematico.
Particolarmente preoccupante è la tendenza a raccontare questi crimini come eventi eccezionali, frutto di follia o passione incontrollata, quando i dati dimostrano che si tratta di fenomeni strutturali spesso preceduti da segnali riconoscibili. Come sottolineato dalla sociologa Chiara Volpato, “il femminicidio non è il gesto isolato di un folle, ma l’estrema manifestazione di un continuum di violenza radicato nella cultura”.
Educazione e prevenzione
Il contrasto alla violenza di genere deve necessariamente passare attraverso l’educazione. Le scuole rappresentano un contesto fondamentale per destrutturare gli stereotipi e promuovere relazioni paritarie. Programmi di educazione emotiva e affettiva nelle scuole superiori hanno dimostrato di ridurre del 28% gli episodi di violenza tra adolescenti.
Un cambiamento culturale richiede interventi su più livelli:
- Formazione degli insegnanti su tematiche di genere
- Programmi scolastici che includano educazione all’affettività
- Campagne di sensibilizzazione che coinvolgano l’intera comunità
- Rappresentazioni mediatiche responsabili e consapevoli
Solo attraverso un approccio sistemico che metta in discussione le norme sociali che legittimano la violenza sarà possibile interrompere il ciclo di sopraffazione che ancora oggi conduce troppe donne alla morte.
Risposte istituzionali e quadro normativo
L’Italia ha progressivamente rafforzato il proprio sistema normativo di contrasto alla violenza di genere, allineandosi agli standard europei attraverso una serie di interventi legislativi significativi.
Evoluzione del quadro normativo italiano
Il percorso legislativo italiano ha visto diverse tappe fondamentali:
- 2001: Introduzione del reato di “maltrattamenti in famiglia” (art. 572 del codice penale), primo riconoscimento formale della violenza domestica come reato perseguibile
- 2009: Approvazione del decreto legge che ha introdotto il reato di stalking (art. 612-bis del codice penale), con pene fino a quattro anni di reclusione
- 2013: Ratifica della Convenzione di Istanbul e approvazione del Decreto Legge n. 93/2013 (convertito nella Legge n. 119/2013), noto come “Decreto Femminicidio”, che ha introdotto misure per prevenire la violenza di genere e proteggere le vittime
- 2019: Entrata in vigore della Legge n. 69/2019, denominata “Codice Rosso”, che ha rivoluzionato l’approccio al contrasto della violenza introducendo procedure più rapide per le denunce e nuove fattispecie di reato come la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn) e la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
- 2021: Potenziamento delle misure preventive come il braccialetto elettronico e l’ampliamento delle circostanze aggravanti
Strumenti di protezione e supporto
L’ordinamento italiano prevede diversi strumenti a tutela delle vittime:
- Ordini di protezione e allontanamento: misure cautelari che impongono all’aggressore di lasciare l’abitazione familiare e vietano l’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima
- Centri antiviolenza e case rifugio: strutture che offrono accoglienza temporanea e supporto psicologico, legale ed economico alle vittime
- Congedi lavorativi specifici: permessi retribuiti per le donne vittime di violenza, introdotti dal D.Lgs. 80/2015
- Patrocinio gratuito: assistenza legale senza oneri per le vittime di violenza, indipendentemente dal reddito
- Numero di emergenza 1522: servizio pubblico attivo 24 ore su 24 per fornire supporto e informazioni alle vittime
Criticità nell’applicazione delle norme
Nonostante i progressi legislativi, permangono significative criticità:
- Vittimizzazione secondaria: molte donne che denunciano subiscono un trattamento inadeguato da parte delle istituzioni, con minimizzazione del rischio o colpevolizzazione
- Formazione insufficiente: mancanza di preparazione specifica degli operatori (forze dell’ordine, personale sanitario, magistrati) nell’identificare e gestire casi di violenza di genere
- Tempi giudiziari: eccessiva lentezza dei procedimenti che mette a rischio l’incolumità delle vittime durante l’attesa
- Carenza di risorse: finanziamenti insufficienti per centri antiviolenza e case rifugio, con una distribuzione disomogenea sul territorio nazionale
- Valutazione del rischio: assenza di protocolli standardizzati per valutare la pericolosità degli aggressori e il rischio di recidiva
| Aspetto | Situazione attuale | Criticità |
|---|---|---|
| Normativa | Quadro completo (Codice Rosso) | Applicazione non uniforme |
| Centri antiviolenza | 335 centri in Italia | Distribuzione territoriale disomogenea |
| Misure cautelari | Allontanamento e divieto di avvicinamento | Monitoraggio insufficiente |
| Formazione | Prevista dal Codice Rosso | Attuazione parziale |
Proposte di miglioramento
Per rafforzare l’efficacia del sistema di protezione, esperti e associazioni propongono:
- Prevenzione primaria: introduzione dell’educazione all’affettività e al rispetto di genere in tutti i cicli scolastici
- Formazione obbligatoria: percorsi formativi specifici e continui per tutti gli operatori della rete antiviolenza
- Coordinamento interistituzionale: creazione di tavoli permanenti tra magistratura, forze dell’ordine, servizi sociali e centri antiviolenza
- Sostegno economico strutturale: potenziamento dei finanziamenti per l’autonomia economica delle vittime (formazione professionale, inserimento lavorativo, soluzioni abitative)
- Percorsi per maltrattanti: implementazione di programmi obbligatori di riabilitazione per gli autori di violenza, con monitoraggio dell’efficacia
- Sistema informativo unificato: creazione di una banca dati nazionale che raccolga tutte le denunce e gli interventi, permettendo una valutazione complessiva del rischio
L’esperienza internazionale suggerisce che l’approccio più efficace è quello integrato, che combina repressione, protezione e prevenzione. La Spagna, con la sua legge organica sulla violenza di genere del 2004, rappresenta un modello di riferimento per la specializzazione delle strutture giudiziarie e l’approccio olistico al problema.
Suggerimenti per la struttura del tema e per una scrittura efficace
Affrontare un tema sul femminicidio richiede un’organizzazione chiara e una trattazione sensibile. Per strutturare efficacemente il tuo elaborato, segui questi passaggi fondamentali.
Pianificazione dell’elaborato
Prima di iniziare a scrivere, dedica tempo alla comprensione della traccia e all’organizzazione delle idee. Identifica la tipologia richiesta: un tema argomentativo (tipologia B) richiederà l’analisi di documenti forniti, mentre un tema di attualità (tipologia C) permetterà una maggiore libertà espositiva.
Schema consigliato:
- Introduzione (10-15% dell’elaborato): definisci il femminicidio citando fonti autorevoli come Russell o Lagarde, presenta brevemente l’estensione del fenomeno e anticipa la tua tesi principale.
- Corpo del testo (70-75%): suddividi in 3-4 paragrafi tematici con titoli esplicativi, alternando dati statistici e casi concreti.
- Conclusione (10-15%): sintetizza i punti chiave e proponi soluzioni educative e legislative concrete.
Stile e linguaggio
Il tema richiede un registro formale ma accessibile, evitando sia la freddezza accademica sia il sensazionalismo giornalistico:
- Utilizza terminologia appropriata: “femminicidio”, “violenza di genere”, “dinamiche di potere” anziché “omicidio passionale” o “tragedia familiare”.
- Evita generalizzazioni non supportate da dati.
- Costruisci periodi brevi ed efficaci, privilegiando la chiarezza espositiva.
- Usa connettivi logici per guidare il lettore: “Pertanto”, “D’altra parte”, “In contrasto con”, “Di conseguenza”.
Errori comuni da evitare
Nel trattare questo tema delicato, evita:
- Ripetizioni lessicali eccessive (usa sinonimi appropriati).
- Periodi troppo complessi con subordinate multiple.
- Commenti che potrebbero suggerire colpevolizzazione della vittima.
- Affermazioni non supportate da fonti verificabili.
- Confusione tra correlazione e causalità nelle analisi statistiche.
- Errori grammaticali ricorrenti come “qual’è” (corretto: qual è) o “un’altro” (corretto: un altro).
Esempi di aperture efficaci
“La statistica racconta una verità allarmante: in Italia, una donna viene uccisa ogni tre giorni in quanto donna. Il femminicidio rappresenta l’apice di una violenza sistemica che attraversa la nostra società, radicata in stereotipi e disuguaglianze di genere profondamente sedimentati.”
“‘Dietro ogni statistico sul femminicidio c’è una donna che ha vissuto, sperato e sognato’, scriveva Elena Biaggioni. Questa consapevolezza deve guidare l’analisi di un fenomeno che nel 2023 ha causato oltre 100 vittime nel nostro paese.”
Traccia svolta su violenza delle donne e femminicidio
INTRODUZIONE
Per prima cosa pensiamo all’introduzione, breve ma efficace in cui puoi spiegare che cos’ è il femminicidio. Il femminicidio è un termine usato per identificare una violenza di genere che ha come oggetto le donne ed è considerato un crimine brutale, solo da poco tempo identificato come una vera e propria violazione dei diritti umani. Si tratta di un’aberrazione che finalmente sta venendo alla luce dato che sempre più spesso telegiornali e trasmissioni televisive danno spazio a casi di donne che non hanno saputo o potuto difendersi e che hanno perso la vita per mano di una persona a loro familiare.
SVOLGIMENTO
Per lo svolgimento, invece, ti consigliamo di analizzare qualche dato, Ogni tre giorni, in Italia, una donna viene uccisa da un marito, un fidanzato, da un compagno o ex compagno di vita. La domanda sorge spontanea anche se la risposta spesso ci lascia attoniti: perché un uomo arriva ad ammazzare la sua compagna, la madre dei suoi figli, accecato dall’ira, dalla rabbia o dalla gelosia? Come può un uomo che ha amato spingersi così oltre? Per quanto banale, la risposta più semplice sembrerebbe essere anche la più efficace: da un lato c’è la forte insicurezza, la paura della perdita e dell’abbandono da parte di un uomo che non si fa fatica a definire debole, dall’altro c’è l’impotenza, lo smarrimento, la sottomissione di una donna che non riesce a trovare il coraggio di ribellarsi.
Cosa che però sembra più facile dirsi che farsi perché possiamo immaginare che in un contesto di continue violenze, subentrino meccanismi di sopravvivenza e sottomissione che è difficile delineare dal di fuori. Se penso ad una violenza così brutale da sfociare in un crimine vero e proprio, penso ad una donna che ha sognato l’amore e che si ritrova a subire umiliazioni e dolori tra le mura della propria casa, in luoghi familiari dove dovrebbe invece sentirsi protetta. Protetta soprattutto da colui a cui ha legato la propria vita. Immagino che magari si possa credere di poterne uscire da sole, ma non credo sia possibile. Oggi esistono molti centri di supporto psicologico per le donne che hanno subito maltrattamenti, che hanno denunciato e che si sono salvate da un terribile destino. Immagino che ci si debba sentire spezzate, ferite, alienate, spiazzate, ma questo non deve in alcun modo avere il sopravvento. Eppure sono moltissime le donne che periscono per mano di coloro che dicevano di amarle e questo mi spiazza al punto da lasciarmi quasi incredula.
Da donna cerco di mettermi nei panni di un uomo che si rifugia nella violenza, in una esistenza di dolore e rabbia, ma davvero non posso ammettere che una persona pensi di possedere un’altra, che possa pensare che quella donna non possa vivere e respirare anche senza la sua presenza, e in questi casi, diciamolo, forse sarebbe vita con la maiuscola senza una persona negativa come questa!
CONCLUSIONE
Infine, per concludere il tuo tema sulla violenza sulle donne ti consigliamo di approfondire il tuo punto di vista dando ulteriore spazio alle tue riflessioni, magari provando a ipotizzare una via percorribile per migliorare la situazione. Come ci si libera di un uomo violento, come si può evitare di morire a causa di un uomo impaurito, insicuro, debole?
Metterlo nero su bianco mi fa riflettere: non è facile. Basterebbe amor proprio, fiducia nelle istituzioni, coraggio, ma sfido chiunque a subire tali violenze e a trovare la forza per uscirne. Ci sono numerosi casi di femminicidio nel mondo e ogni donna ha la sua personalissima storia. Generalizzare forse è scontato, ma in minima parte, forse banalmente, credo che l’unica via di uscita sia cercare ad ogni consto di riconquistare la propria dignità, lottare per il proprio futuro e non arrendersi a chi vuole vedere una donna consumata e infelice.
TEMA SULLA VIOLENZA SULLE DONNE E SUL FEMMINICIDIO: TRACCE SVOLTE PER IL TEMA DI ITALIANO
Se sei interessato all’argomento e vuoi approfondire questa attuale tematica per svolgere un tema o per trovare altri spunti, oppure hai bisogno di un altro punto di vista per ampliare le tue riflessioni, ti consigliamo alcuni link utili:
- Tema sulla Violenza Psicologica sulle Donne
- Tema sulla violenza sulle donne tracce svolte
- Tema sulla violenza sulle donne: appunti, casi reali e svolgimenti
- Tema svolto: la violenza sulle donne
- Saggio breve sulla violenza sulle donne
TEMA SULLA VIOLENZA: Se dovesse servirti un tema sulla violenza, eccone uno già svolto da cui prendere spunto:
TEMI SVOLTI: TUTTO PER I COMPITI- Hai bisogno di altri temi svolti? Nessun problema, basta cliccare i link giusti: Temi svolti di Attualità